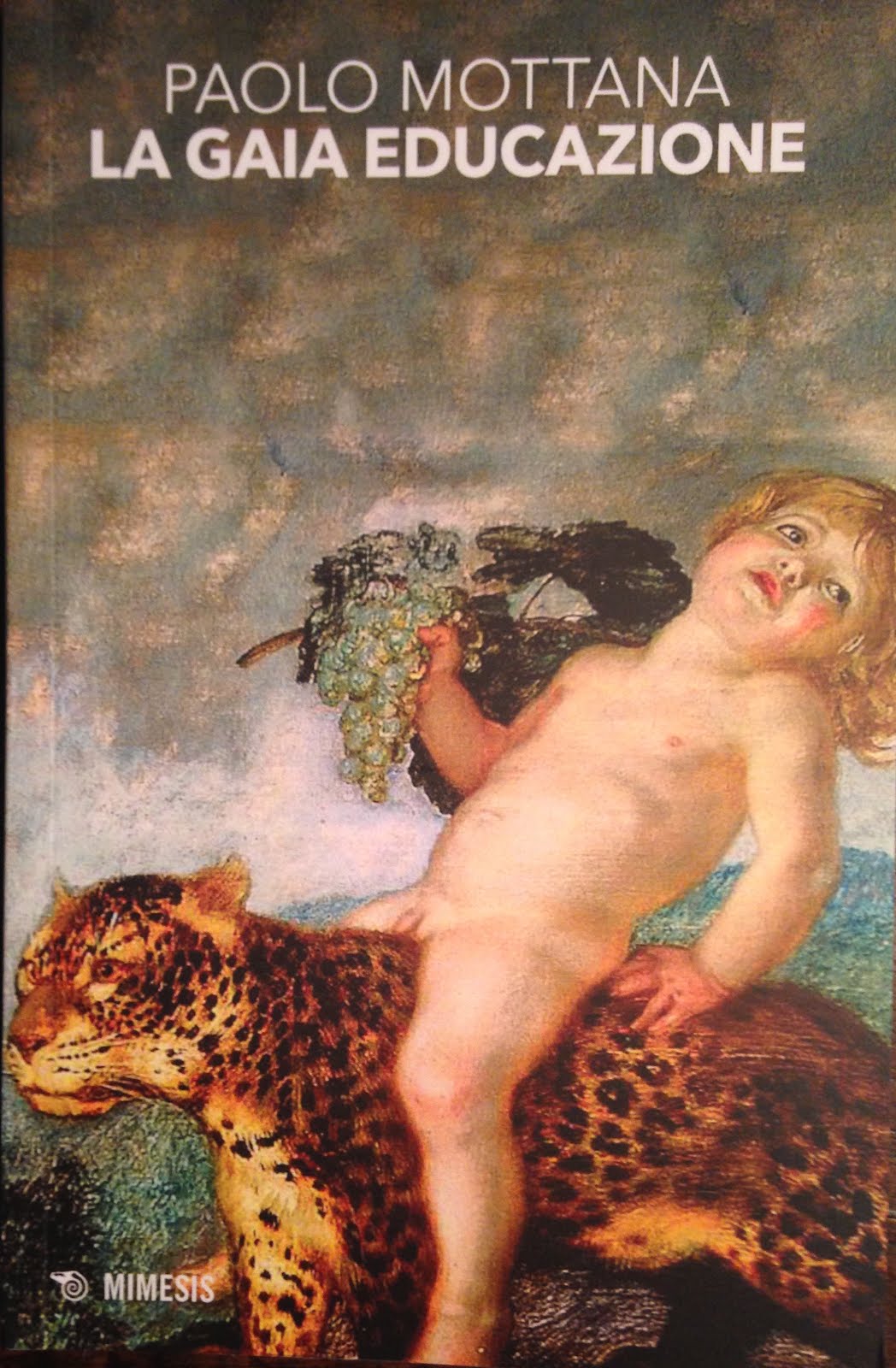L’evidenza è che il “bastardo educante” è ovunque. Così è sempre stato ma ora è peggio. Guardati in giro. Tu sei il frutto di tutto quello che si trova intorno a te, immobile o in divenire. Guarda i tuoi muri e i tuoi manifesti, guarda le tue scarpe abbandonate sul pavimento. Guarda il colore alle pareti, la stoffa sulle poltrone, la materia dei pavimenti, guarda la tua libreria ma non guardare quello che c’è nei libri, guarda i loro volti, le loro dimensioni, la loro materia. Tutto questo ti fa. Eccome.
Per non parlare delle colonie di genitori che spuntano ovunque, mascherati da fratelli, gemelli, maestri, parenti, imbonitori. Poi c’è la pletora degli orifizi, degli occhi che si aprono sull’etere: pozzi da cui sbuca la vita diminuita.
Ne sei circondato, li tieni in mano, ti si rovesciano addosso. Tu sei il loro bersaglio e, a volte, il loro monitore. Ma il circuito è stracarico. Ti sei affollato davanti alla tv, e sei stato colpito. Qualche volta hai goduto ma, perlopiù, sei caduto nel nulla. Così girano le cose: nelle strade, ad alta velocità, e non sono più innocue. La loro velocità ti modella, come può fare un grosso tornio su una pellicola di rame. Tu sei rame sottile, comunque con un certo potenziale. Potenza di superamento. Ma tutto congiura a immobilizzarti, a renderti un commestibile per mascelle sempre in moto. Lo vedi: le tue scelte. Anzitutto neppure le parole. Le hai già in bocca, scorrono fuori e tu non le sai. Ne avverti il sapore? Dubito: sono insapori, al tuo gusto. E invece hanno veleno da vendere. Parole che ti abusano impercepibilmente e con cui tu ammorbi un uditorio che non ti ascolta. Quando ti ascolta è per una parola nuova, che tu però non hai.
Avverti i tuoi gesti? Sono preconfezionati. Non sai dire dove li hai comprati perché ti si sono attorcigliati addosso come serpenti, mentre come un sonnambulo percorrevi i corridoi bui della tua vita assediata. Non sei un nittalope, sei un cieco. In un vicolo cieco. Il viottolo dello stordimento. Non sai cosa maneggi, cosa mangi, cosa tocchi: tutto ti è estraneo e non ne conosci la sorgente. Sempre che una sorgente ci sia.
Non c’è modo di sbarazzarsi della bava di questo mondo fittizio, mondo ortopedico che ti calza addosso come una cintura di castità e ti toglie l’aria. Il tuo deretano sa distinguere una poltrona o un coccio di vetro? C’è di che dubitarne. Sei un pezzo di anestesia allegramente in circolazione, beotamente ignaro.
Come puoi fabbricarti anticorpi per non essere saccheggiato tutto il giorno dalla tua stessa inettitudine? Per non essere la vittima della tua sbadataggine mutuata nell’assenza? Compito duro che chiede duro tirocinio. Non si costruisce un’attenzione intorno a una distrazione radicale. Bisogna fare un buco nella muraglia che ti circonda, quella che non vedi. E poi annusare. L’olfatto è sempre un buon indicatore, ad averlo ancora vivo. Una regola dell’autocontroeducazione è: cura l’olfatto. Allenati, con quello che hai intorno. All’inizio non sentirai nulla, solo fantasmi di giudizi troppo banali per essere attendibili: sento odore di polvere, sento odore di cibo, sento odore di cesso. Tutto sbagliato, tutto da rifare. E tu lo sai bene. Ognuno di questi coaguli di segni è un cosmo di fili incandescenti pronti a colpire le tue vibrisse ma il tuo naso è davvero troppo piccolo per albergarli anche solo in parte. Allora: matura il naso. Crescilo, non lasciarlo vagabondare come un pinguino cieco in mezzo alla brughiera di notte. Installalo al centro delle tue cure. Fanne un’antenna ad alta portata. Costringilo a frugare la foresta corallina di spruzzi odorosi che si avviluppa a tutta intera la materia che ti circonda. Per ottenere ciò, però, piano piano, dovrai dissolverti. Non esserci con i brontolii sordi di quella crisalide unta che chiami io. Fai esercizio di non-io. E il primo esercizio è: annusa.

Come proteggersi dall’assalto a fauci spalancate della polluzione di orifizi inutili, quella infausta pletora di schermi dalla quale siamo assediati? Ritrovando la gravitazione. Sii un corpo diffuso ma prima: sii corpo. Come puoi distinguere dentro un buco di vetro di pochi millimetri senza prima aver allenato il corpo all’autoascultazione profonda? Cosa fai quando la nube dell’insoddisfazione ti avvelena come il gas nervino delle tue stesse bugie? Come fai ad accorgerti se sei in piena centrifuga di panico o se il petto ti insuffla miele rovente fino all’inguine? Non è facile. Spesso patisci fingendoti goduto.
Lo dice la tua pancia, in contrazione acefala. Lo dice il disegno che compili con l’alluce sulla superficie dell’aria come il miglior pittore senza braccia. Lo dicono i tuoi denti in stridore permanente mentre nella mente ospiti il condominio di scene incorporate in apnea dal tuo ultimo dispositivo di iperconnessione. Candido subzoico che procedi ignaro verso l’autodistruzione, credimi, devi allenare il corpo. Fargli l’addestramento a reclamare il giusto spazio nell’economia della tua saturazione inesausta. Allenare il corpo significa accartocciarsi come un grande organo senziente su di lui, e poi sopra quello di tutto il resto. Impara a sentire come sta il tuo radio, cosa dice la tua ipofisi, come vibra quella maledetta staffa quando le propini le frustate delle tue manie metalliche. E poi impara a indagare l’opinione del tuo esofago quando inghiotti le consuete chimere di proteine senza averle tradotte in stupore e sapore.
Poi dilata quelle pupille intasate: indaga la fioritura di fuliggine delle tue pareti, sorvegliane l’odore. Resta a lungo sulla vagina dei tuoi fiori, finchè non rivela la chiave esatta della sua combinazione cromatica. Come potrai decifrare l’occhio interminabile della tua beneamata senza un tale addestramento, o il sapore dei suoi ginocchi, se non l’avrai sperimentato in proprio, a lungo leccando e tastando con le papille il dorso fragile di una prugna, senza aver intinto la lingua nel mosto d’uva cotto? Hai perduto la temeraria confidenza di bambino con l’immersiva bellezza del gusto sabbioso e acuto della ghiaia, con le poltiglie odorose di bava, con i rossetti e lo sterco che ancora non istigava il tuo grillo parlante a rimuovere tutto ciò che sa di sudicio, per indirizzarlo al limbo dei diseredati? Sii più sapiente, altrimenti non saprai manovrare il piacere dei cibi e dei corpi, delle carezze di sole e delle piogge abbondanti. Non saprai distinguere la storia di maneggi impressa sopra il libro che stai leggendo e nemmeno la nebbia sapida delle serate in fondo a un’osteria ancora impregnata di cotture, di fritture, di effluvi speziati.
E dunque, allargando, è questa la seconda prescrizione: amplifica il tuo corpo, per l’ampio e per lo spesso, addensane la trama e stendilo come una pellicola sensibile sopra il corpo del mondo, fino a che non faccia gloriosamente tutt’uno con esso.
Poi, quasi infine, ma non c’è infine all’apprendimento delle cosce calde del mondo, del suo seno giovanile e immensamente morbido. Ad apprenderne i linguaggi, le forme, la materia mobile e incatturabile. Eppure infinitamente godibile.

Impara l’immaginazione. A immaginare ci vuole orecchio, e tatto, e gusto, e olfatto, prima ancora che gli occhi. L’immaginazione non è una faccenda di immagini visive: dietro l’immaginazione c’è la fisiologia delle cose, l’avvertimento delle risonanze, un udito così sottile che percepisce il brontolio sordo degli stomi sulle foglie, quando l’albero dorme.
Immaginare è perforare ancora una volta il busto di piombo che l’anestesia diffusa ha piantato sopra la pelle della vita. Immaginare come diviene, quella vita, dove attinge i suoi spasmi, come pulsa, come si irradia. Non c’è immaginazione che cavalchi nel vuoto. L’immaginazione non è saturazione di un buco. L’immaginazione è trapianto del fiore della tua sensibilità proprio in mezzo alle correnti profumate che trattengono la terra nella sua rotta, perché non ceda.
Immaginazione è cogliere la pelle del tuo amore come l’alfabeto stellare e, al tempo stesso, come la propagazione di luce che corre nelle fibre di un prato. Immaginazione non è sturare il lavandino delle tue inestinguibili manie di dominio, piuttosto è abbandono, dissolvimento, cedimento all’assalto innumerabile di quel pulviscolo che prima incatenavi alla macina di mulino di un’unica parola. Immaginazione è ancoraggio e poi flusso, perdita e improvviso ritrovamento, pulsazione di istanti in una scia instabile ma persistente. Non c’è immaginazione senza sensibilità, senza quel lungo e paziente ascolto degli alfabeti sommersi dei corpi, corpi viventi minerali e stellari, semoventi e immobili, sonori e danzanti, gonfi di umori, rivestiti di tegumenti, palpabili, inalabili, copulabili.
Immaginati in piena ardente fornicazione con la grande mammella terrestre, la tua pelle ipersensibile esposta alle mille vellicazioni della piovra vegetale, allo scorrimento penetrante del vento, al fragore del respiro del tuo amore, quando gode, quando sorride.
Immaginare fino in fondo, lungo le superfici, minuziosamente, pienamente, intensamente. Per fare sapore, per far denso il silenzio, per annegare il mare.
Esausti, avremo acceso le prime aperture nella barriera che ci ottunde e ci depriva.
Organizza i gesti della tua personale, ormonale, aromale controeducazione!