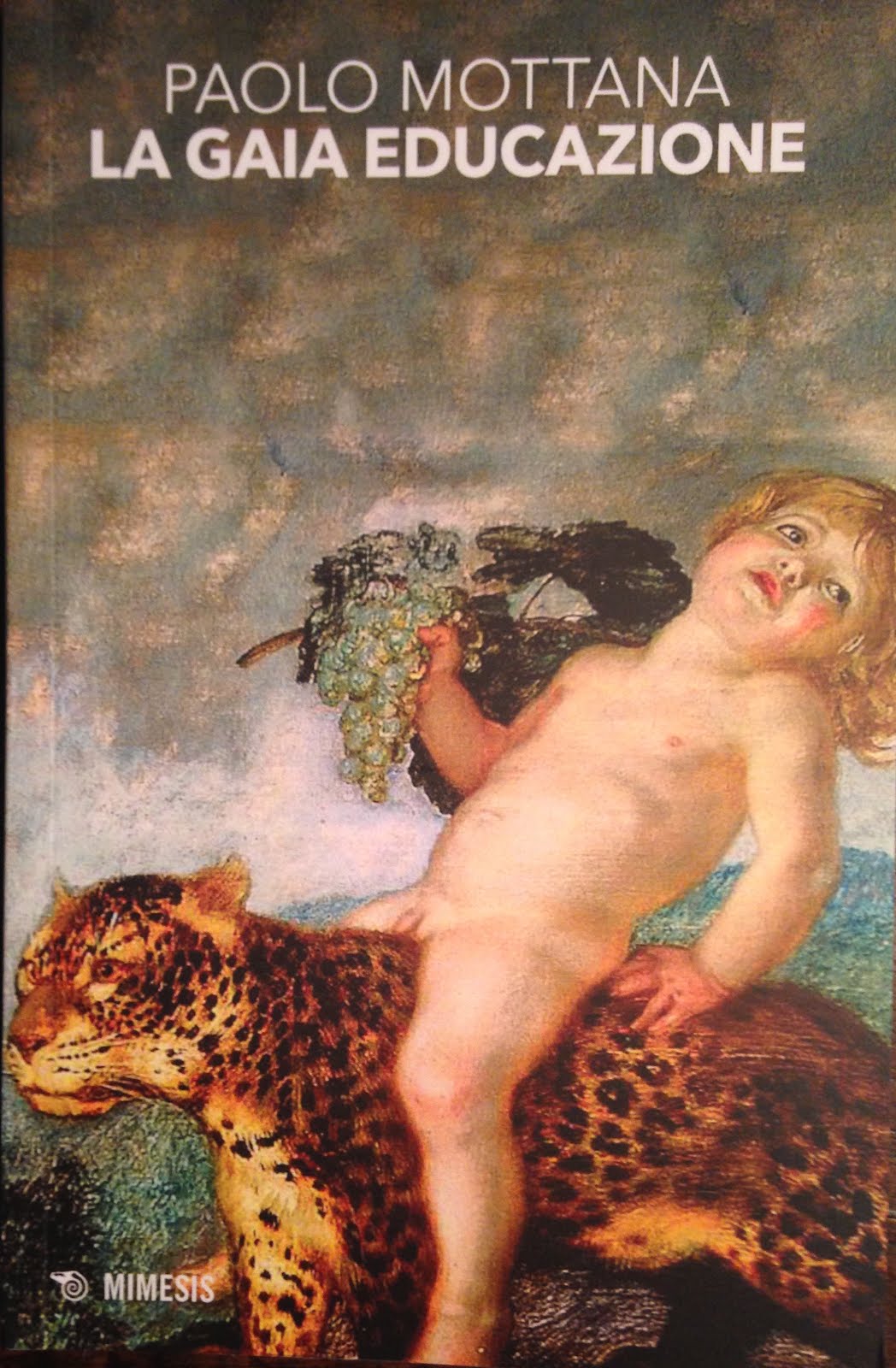Sembra che stupisca (cfr. Mila Specola nel suo blog “La ricreazione non aspetta” del 7 gennaio) il ragazzino che chiede alla professoressa che senso ha studiare quando i titoli si possono comprare e il successo arride ai corrotti… (con riferimento al caso Belsito e ad altri simili narrati dalla cronaca recente).
Questo è quanto appare sulla scena delle scuole italiche. Fenomeno più acuto certo ma probabilmente stabilmente consolidatosi, almeno dai tempi in cui calciatori e veline la facevano dai padroni nell’immaginario dei più giovani. Come modelli da imitare (e non è cosa di oggi). Questione che interroga sul divario tra immaginario diffuso e il possibile immaginario che la scuola dovrebbe proiettare attraverso l’orizzonte inesauribile della cultura ma che purtroppo la scuola stessa non sembra essere in grado di rendere competitivo.
Questione complicata, e spinosa. Lo sappiamo: i ruoli che solitamente appaiono appropriati a chi studia diligentemente, dal filosofo all’avvocato, dall’insegnante allo scienziato, sono piuttosto in disarmo, da tempo. Realisticamente, il successo “facile”, se di facilità si può parlare, di chi sceglie altre strade o scorciatoie, appare obiettivamente più appetibile.
Qui tuttavia bisogna stare molto attenti a distinguere, a non sottovalutare nulla ma neppure soffermarsi con lo stesso accento su argomenti e casi che sono spesso molto diversi.
La questione è: si tratta di autentici esempi di successo? E poi, che significa il successo? E cosa è un successo comprato?
Consideriamo l’esempio di calciatori e veline, o tronisti e modelle.
Sono immagini luccicanti ma dietro le quali si accalcano molte ombre.
Forse che essere un calciatore di successo è una cosa facile, come in tutte le discipline di sport professionistico? In realtà si tratta di un numero estremamente esiguo di soggetti, quelli che arrivano ad un autentico “successo”, che pagano in moneta sonante la loro fama, con anni e anni di sacrificio assoluto, di totale dipendenza da un sistema che letteralmente dispone delle loro vite e che poi, fin troppo spesso, li abbandona alla deriva, quando appaiono troppo vecchi (sui 35 anni) o malandati per poter continuare. Spesso senza molte altre serie prospettive di futuro.
Le veline (o i tronisti) sono esempi diversi, di carriere apparentemente facili ma anch’esse segnate dal sacrificio non irrisorio di avere venduto la propria faccia, il proprio corpo, la propria intimità. Analogamente a molti sportivi professionisti, per un piatto di lenticchie che spesso dura assai poco e che finisce prima di quanto non si creda: in assenza di una professionalità solida, esso si spegne talora nella depressione e in una vita da ricostruire da zero.
Per non parlare poi della disciplina durissima cui si devono sottoporre, come anche le modelle, per essere competitive in una gara che ne lascia moltissime sulla strada e che vede anche quelle che riescono ad ottenere il successo, alla mercé di padroni e di produttori di pochissimi scrupoli, cui debbono spesso pagare il proprio protagonismo in forme non sempre castigate.
Diversamente, i Belsito, i Fiorito e tutta la compagnia dei politici che “arrivano” in virtù di mazzette, di raccomandazioni, sono esempi più difficili da smontare. Ma anche qui occorre guardare il fenomeno con un occhio più smaliziato: questi individui, per accedere al loro presunto “successo” o potere, devono prima subire infinite vessazioni, devono inchinarsi - anzi inginocchiarsi - davanti a figure che non si peritano certo dall’esercitare massicciamente la pratica dell’umiliazione. Devono far la fila, devono saper essere infinitamente ipocriti (e non è sempre così facile), devono vendere continuamente fumo (e anche questa non è un’abilità da tutti).
Insomma, anche per la corruzione è necessario uno specifico talento. Ma soprattutto, quello che va evidenziato e che è davvero insostenibile, è ciò che questi personaggi diventano effettivamente. Cosa diventa la loro vita.
Perché il prezzo da pagare a queste ipotetiche “fortune” è che si tratta di successi che tutti quelli che vivono in quell’ambiente sanno bene da dove vengono. Successi falsi, il cui costo si percepisce nelle espressioni di chi li circonda, devoti davanti e irridenti dietro. Dal fatto che la fiducia nei loro confronti sarà sempre solo un fenomeno di facciata. Che vivono circondati dall’invidia e dal feroce desiderio di vederli annegare al più presto. Che sanno fin troppo bene che chi si avvicina a loro lo fa solo per il fatto che dispongono di un potere che oggi c’è ma domani potrebbe scomparire.
E tuttavia, il vero dubbio che sorge, immaginando lo scenario delle classi dove i nostri ragazzi confusi e disorientati si affacciano al mondo del sapere e della vita, è un altro. Siamo sicuri che queste domande, queste questioni non sorgano anche e soprattutto perché lì, in quelle aule, in quelle classi, non si riesce in nessun modo a restituire lo splendore senza pari che la cultura, la grande meravigliosa cultura di cui potremmo essere tutti devoti e appassionati discepoli, irradia?
Non è che il fascino di Belsito o dei suoi modelli sia forse anche effetto del fatto che qualunque cosa, persino la miseria così evidente di questi personaggi, appare migliore che dover patire giorni e giorni di tedio in aule plumbee, a sorbire riduzioni e liofilizzati solo lontanamente imparentati con la bellezza raffinatissima di una cultura tra la più ricche del mondo?
Il problema non sta forse a monte? Nell’inadeguatezza della scuola, e forse di un’ intera società, di condurre davvero alla cultura, unica autentica modalità per perfezionare la propria vita prima ancora di qualunque successo professionale, unica via per poterla anche solo vivere veramente, al meglio, riuscendo a percepire l’infinita e inesauribile trama di corrispondenze, di analogie, di pieghe e di sfumature che la rendono degna di essere vissuta?