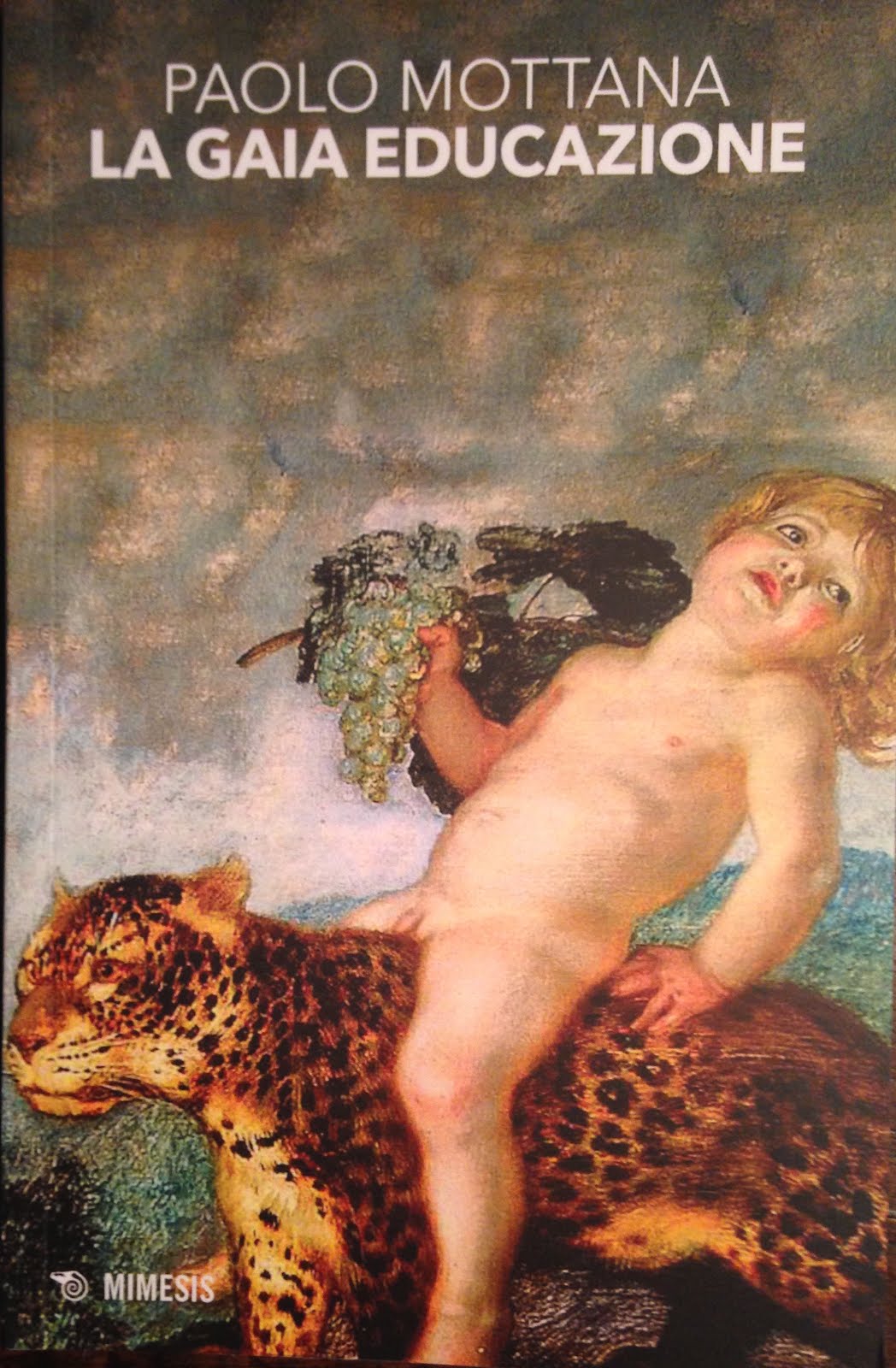Guardandomi in giro non trovo più sguardi. Né quelli apatici di chi rotola mesto al lavoro. Né quelli garruli di chi rimugina una qualche fortuna. Né quelli torvi di chi odia il prossimo ( e anche il distante), né quelli curiosi di chi ti esplora con attenzione, né quelli timidi di chi guarda di sfuggita, obliquamente, o, talora, in tralice.
La verità è che l’esperienza di guardare ed essere guardati è totalmente tramontata. Non perché si sia diventati ciechi. Assolutamente no. Semmai perché gli occhi sono stati ingoiati da quei prodigiosi apparecchi che sono i moderni cellulari. Piccoli, maneggevoli e potentissimi strumenti di alienazione terminale dello sguardo.
Osservo le persone in auto, dal momento che vi trascorro ahimè molto tempo. Una percentuale altissima è al cellulare, alcuni per parlare (per un tempo incredibilmente interminabile, mi chiedo sempre su quali conti vadano chiamate di tale lunghezza), altri per vedere, digitare, accarezzare per far scivolare le molte finestre e finestrine e finestrinine dell’ingegnoso strumento.
Per strada, sugli autobus, nelle stazioni è anche peggio. Ovunque non si incontrano più sguardi ma corpi immersi nel flusso microscopico e magnetizzante dei loro cellulari. E se per caso si scopre qualcuno che non è adeso all’oggetto, anche se lo tiene quasi sempre comunque in mano, come una specie di fallo sostitutivo (specie le donne, va detto), ecco che, di fronte all’insolenza del mio sguardo, subito la difesa è fuggire nel piccolissimo schermo, l’ultimo di una catena di rimpicciolimenti nel campo della comunicazione(dal grande schermo, il cinema, al piccolo schermo, la tv, allo schermo micro, l’androide o aifono che sia).
Non si veda in ciò un rigurgito si moralismo. A scanso di equivoci anch’io possiedo un cellulare, androide credo, e lo uso, per quanto con una parsimonia tale che certi giorni neppure mi accorgo della sua esistenza. In gran parte parte perché ancora mi rifiuto di leggere la mia posta, i messaggi, le notizie e tutto il resto dentro quel miserabile schermo ma, soprattutto, perché ancora le mie dita non hanno sviluppato l’abilità tutta contemporanea della scrittura su microtasto. Imperciocché perderei tempo e vista a mettere insieme anche poche frasi spesso rischiando, con l’uso del T9, di sbagliare molte parole accorgendomene troppo tardi.
In verità però c’è anche dell’altro. Oso appena mormorarlo: inspiegabilmente, contro ogni evidenza, credo che il mondo là fuori sia più interessante delle per quanto mirabolanti infinite possibilità di acciuffamento di novità, messaggi e chattamenti vari il cellulare possa mai predisporre per me (fatte salve le urgenze). In fin dei conti il mondo del possibile, per quanto brutto possa essere, e spesso lo è, eccome, è quello là fuori. Quello nel microschermo è comunque il mondo piccolo, privato, a uso e consumo della mia petizione, delle mie intenzioni, per quanto lontano si possano spingere. E tutto sommato pur sempre un mondo che fatica molto ahimé, a trasmutarsi da fantasmatica virtualità in concreta e carnale consistenza.
Non essere ri-guardati è un’esperienza che travalica di gran lunga lo shock di cui parlava Walter Benjamin. Non più solo sguardi vuoti o assenti, ora proprio non sguardi. Perché per quanto, negli attriti imprevedibili della folla, di tanto in tanto uno scambio di sguardi, un bagliore di reale impertinente, prima dell’avvento dei microschermi, ancora poteva essere incontrato. Ora non più. Oltre al fatto che il contatto continuo con la parata molteplice delle scene del cellulare, di cui certo non può essere negato il fascino, pari a quello di un moderno caleidoscopio, è comunque un lavoro, un’attività, che non consente mai di riposare, di defluire, di calare nel mondo semplicemente per sostarvi inattivi, passivi, immemori (oppure memori ma di qualcosa che non ci piova addosso dal cellulare).
Insomma il cellulare, anche se certo è anche uno strumento che arricchisce il repertorio delle nostre possibilità comunicative, è l’ultima frontiera dell’annichilimento dell’incontro fortuito nel reale. Oggi l’incontro (fortuito?) si dà solo nell’irreale, con tutte le complicazioni che ciò suscita, naturalmente (presentazioni ingannatrici, fake, raggiri di ogni tipo, come è giusto che sia in un ambiente del tutto virtuale).
Trottoliamo nel mondo ignari di tutto, senza più sollevare lo sguardo su ciò che ci circonda (non stupisce allora che l’orrore che ci avvolge possa incrementare ogni giorno la sua proliferazione, in assenza totale di vigilanza (vedasi l’espansione cancerosa degli obbrobri expofili del paesaggio della mia città in questi ultimi anni)).
Ma soprattutto totalmente in opposizione all’altro che non ci viene più incontro, che non più con-è, tanto per dirla un po’ fenomenologica. Perché è del tutto in-line, ben al riparo dall’interlocuzione improvvida tanto quanto da quella provvida.
Chi ha più il coraggio di accendere una comunicazione con qualche compagno di viaggio in treno quando tutti appaiono presi da un altrove illocalizzabile, o comunque affaccendati, con quell’aria compiaciuta di chi può finalmente negare la sua solitudine costitutiva esibendo la parata delle sue gloriose conversazioni (perlopiù imbarazzanti o semplicemente ottuse, come quelle diffusissime con la mamma o il marito/moglie), o peggio, mostrandosi entusiasticamente travolto da una digitazione che appare però più una prestidigitazione (per la incredibile rapidità della tecnica)con un non-si-sa-dove non-si-sa-quando però assolutamente incomparabile con la tenue possibilità di un contatto con chi è lì, magari a pochi centimetri da lui, e che, per colmo della sorte malevola, deve pure sorbirsi le sue chiacchiere o il suo entusiastico diteggiare, a meno di non contrapporre a sua volta la magìa sconfiggi-sfigataggine con un altrettanto roboante tastipestamento orgastico.
Sì è vero prima c’erano i libri a difenderci dal prossimo ma in modo più tenue, più silenzioso e in fin dei conti non del tutto impenetrabile. Dal libro lo sguardo si leva talora, anche solo per rimuginare e riaffiorare al mondo. Dal microschermo non si riemerge più.
L’uomo è finito, diceva un filosofo non proprio di buon umore, un po’ di tempo fa. Ho sempre riluttato a questa sentenza, allevando in me, seppure con una progressiva difficoltà a trovare materia per alimentarla, una sorta di apotropaica speranza nella reversibilità del nulla.
Oggi la materia in mio possesso sta scivolando via come l’ultima sabbia di una clessidra, di fronte a questa razza di cellulare-protesizzati che vagano come sonnambuli in un reale definitivamente lasciato a sé stesso e agli ultimi inevitabilmente depressi testimoni del suo abbandono.
E’ triste non trovare più sguardi con cui scambiare la muta solidarietà dell’essere umani, quella che allude ad un comune destino, magari ingrato, quella di una semplice elemosina di attenzione, o quella più esuberante o intimidita di una seduzione. Nulla di tutto questo è più possibile.
La civiltà dell’ “autos” ha partorito il suo ultimo indefettibile apparecchio di distruzione della “social catena”, quella che sembrava poter magari debolmente contrapporsi allo strapotere di minacce anonime o organizzate, naturali o artificiali che fossero, laggiù nel reale. Oggi c’è una “social catena” in-line, invisibile, imperimetrabile, fondamementalmente autistica. L’hikikimori (quello che si chiude in casa per commerciare con il mondo solo via schermo) è a un passo.
Non so se sia meglio o peggio. Da quello che vedo deve essere meglio. Bisogna che sgomberi i miei dubbi, che smetta di sperare in un ri-guardo che non viene più. Sono proprio un vecchio romantico, credo ancora nel flâneur, nelle derive nel mondo (quello reale), nel sorriso di qualcuno che ti passa accanto o anche semplicemente nel saluto, quello che un tempo (ora quasi più) chi passeggiava si scambiava in montagna (dove però grazie al cielo spesso, ma per quanto? i cellulari non funzionano sempre a dovere).
Basta con questo ciarpame.
L’unica è che faccia un corso di microditeggiatura veloce e mi inchiodi anch’io al mio cellulare, giorno e notte, in auto o in metrò, via dalla pazza folla!