Idee inattese e istruzioni necessarie per rovesciare credenze ossificate, ideologie aberranti e poteri inamovibili e ritrovare l'appetito bruciante, sessuato e nervoso di capire, di fare e di pronunciare il violento sì alla vita che le nostre diseducazioni ci hanno intimato di tacere
la gaia educazione
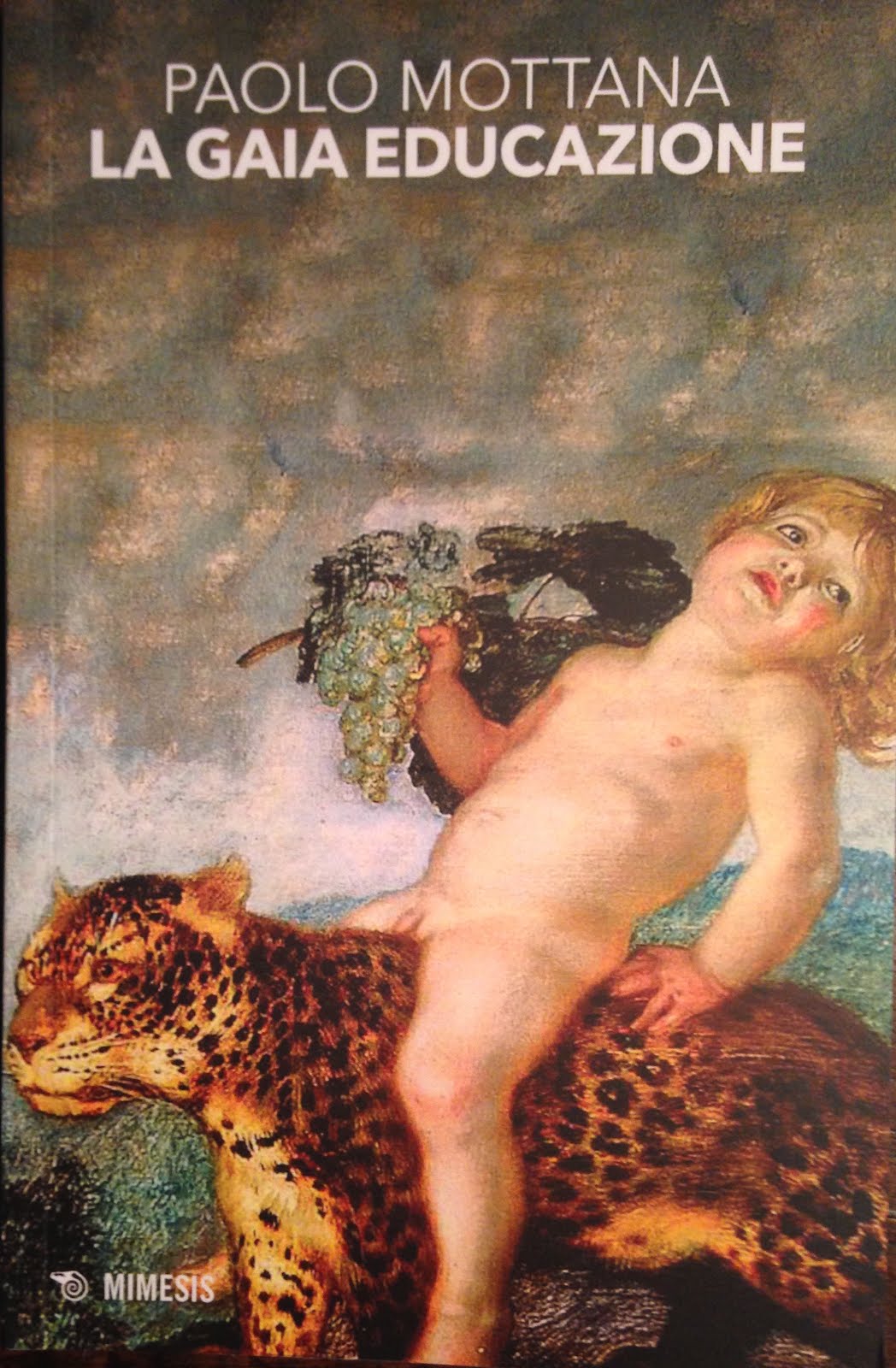
sabato 23 novembre 2013
La grande offensiva dei "talent" : ideologia al quadrato
Ci si accapiglia sui talent perché sono andati a insidiare i territori supposti sacri del nostro mondo ultimo e sventuro. Ma è pura propaganda, serve solo a macinare altra pubblicità. Come se la letteratura e l’arte fossero meno merce del resto. Figuriamoci.
Certo però un dato di tutta evidenza non può essere taciuto. Siamo sommersi.
I talent crescono letteralmente come funghi. Ogni volta che armeggio con il televisore ne scopro uno nuovo. L’ultimo che mi è capitato sottomano è Nati per ballare versione Uk, non so se vecchio o recente, non importa. Soliti formati, genere X factor, solito spettacolo pietoso di personaggi improbabili che si candidano a prestazioni del tutto fuori scala per loro come ciccione che ballano con foga da cardiopalma a ritmo di hip-hop e altre mostruosità analoghe, per rendere la “sfida” ancora più accalorante (del resto Peter Sloterdijk, il filosofo ex-neo-kinico fattosi profeta della talentizzazione di tutti nel suo piuttosto inverecondo Devi cambiare la tua vita, mette in luce come l’handicap sia un prodigioso ingrediente per ottenere prestazioni straordinarie).
Spettacoli di questo tipo grondano letteralmente a fiotti, in una novella uniformazione della materia bulbosa e crassosa che rigurgita cronenbeghianamente fuori dal nostro elettrodomestico più importante.
Ce n’è per tutti e di tutti i generi, dal culturismo all’arte passando per ogni forma dell’umana affermazione nel “fare”.
Ma veniamo al dunque. Chiaro che le polemiche sulla deriva “spettacolare” di campi della nostra esperienza che dovrebbero rimanerne al riparo è del tutto ridicola e, come si diceva, perfettamente in sincrono, per dirla con linguaggio adeso alla materia, con le esigenze mercantili del prodotto. Quindi proviamo a vederne qualche altro aspetto.
Per quanto mi riguarda ritengo che si tratti della più massiccia campagna di propaganda che si sia vista negli ultimi duecento anni a favore di un valore che ritorna a pompare della più bella: il valore della competizione, della competizione individuale e della competizione ad ogni costo. Questo forse è perfino banale. Ma è la misura ad essere straordinaria. La competizione torna e torna alla grande con tutti i suoi accessori: “tutti ce la possono fare” (anche le ciccione che ballano il rap), occorre solo sforzo, umiltà (occorre essere umili di fronte ai giudici, salvo quel pizzico di sfacciataggine che fa sempre audience) e tanta tanta perseveranza.
Naturalmente nel tempo della “grande penuria”: se ce la si può fare, ce la si può fare da soli!
Da non crederci. Era da un po’ che questo valore sempreverde non tornava così beatificato. Rallegriamoci. Ognuno di noi ha un talento e deve vendere cara la sua pelle per farlo valere. Amen
Perno dell’operazione è la gastronomia. Geniale: ci hanno presi per la gola. Chi può affermare di non essere acquolinicamente catturato da quelle belle sfide con chef che sembrano Indiana Jones (Gordon Ramsey, il vero e unico profeta del talent) oppure dei bastardi melliflui e con la pronuncia meravigliosamente slava che tanto fa vecchio film di spionaggio antisovietico (sempre un ottimo bersaglio ideologico, per quanto consumato) come Joe Bastianich?
E’ altrettanto appssionante vedere maltrattare (in chiara simulata) poveri gestori di locali decadenti nelle periferie della California, con le loro cucine sempre piene di cibi surgelati anni addietro e inevitabilmente purulenti e saccheggiati da animali rivoltanti, quanto assaggiare con la sola vista piatti che appaiono perfetti quadri cubisti, salvo che a mangiarli “mi muoro”.
I talent ci appassionano e ci commuovono, stuzzicano la nostra crudeltà quanto il nostro buon cuore. Godiamo a vedere offendere senza mezze misure i contendenti sempre pronti a farsi schiaffeggiare con inscalfibile servilismo così come ci emozioniamo di fronte al ragazzino nero magrolino giubilato dal talent sull’arte contemporanea made in USA, Work of art, che alla fine di un percorso estenuante dove ha dovuto improvvisare in tempi sempre contingentatissimi (secondo le vecchie regole della fabbrica fordista), opere con soggetti impossibili, è finalmente quanto improbabilmente il vincente di una dura lotta a coltello con i suoi competitors.
Di valori a buon mercato ce n’è per tutti i gusti, gusti delle macchine da profitto, si intende.
Una formula che solletica soprattutto il nostro sadomasochismo (ma anche il loro, presumibilmente, dei partecipanti, che fanno la fila per avere una “chance”, vecchio impagabile mito del capitalismo americano), mentre ci identifichiamo di volta in volta con la vittima e con il carnefice. Una formula sicura per fare affari con il mai troppo abusato agonismo da circo romano e, al contempo, rimettere in circolo, a dosi da indigestione, la vecchia e incrollabile ideologia della prestazione, della sfida, della produttività, del vincere o perdere, insomma della competizione.
Ideologia al quadrato in azione: una macchina che fa far soldi e nuovi servi in ogni direzione, da qualsiasi lato la prendi. E in più è anche divertente. Un affare da Re Mida.
Con i suoi “giudici”, tanto per temperare fino all’impossibile la vecchia matita che decreta che la vita è sempre una tenzone con un giudice (per i più paranoici una partita a scacchi). Con un giudice imparziale e “competente” (altra parolina che secerne ideologia come una pera marcia la sua bava sierosa), un giudice che ci rende complici del fatto che ogni opera non è fatta per esprimersi (ci mancherebbe altro) ma per funzionare, e se non funziona, come con inesorabile puntualità i giudici sanciscono, “sei fuori”.
Non stupiamoci. Oggi tornano alla carica tutti i ferri vecchi. Abolita finalmente, anzi proprio surclassata ogni idea che provenisse da quell’impresentabile bacino di puerizia (si fa per dire…) che sono state le lotte degli anni 60 e 70, ormai difese solo da qualche tossicodipendente (quando perfino tutti i suoi principali attori le sbeffeggiano e addirittura le marcano con l’infamia di aver accelerato l’arrivo del peggio presente), è evidente che resta l’unica ideologia, quella vera, quella che non delude mai.
Così tornano alla ribalta con un frastuono che fa fin male alle orecchie il “merito” (applauso), gran campione dell’agone, la prestazione (applauso più forte), unica modalità di essere nel mondo che non sia depressiva e fallimentare e, naturalmente, in questo campionario del principio maschile all’opera nonostante la scomparsa della società patriarcale, la competizione (applausi, fischi, ovazione).
Va così.
Il problema è che tutto questo davvero funziona. Davvero ci piace. E dunque?
Forse che sia tutto vero? Forse che quella vecchia e solo apparentemente indegna ideologia è quella vera, quella santa, quella decisiva?
Basta coi mala tempora currunt, evviva il talent! Facciamoci a pezzi, magari in gruppi, così da dare una degna sepoltura alle fallimentari utopie collettiviste!
Del resto, basta guardarsi in giro, in auto, in tram, negli uffici, nelle scuole, nelle università. E’ tutto un talent, è tutto un fiorire di gare e di giudizi. Ognuno ha il suo X-factor.
Sì, deve essere così, è questo il mondo migliore possibile.
Non resta che allenarsi di brutto.
Etichette:
competizione,
giudici,
Gordon Ramsay,
ideologia,
Joe Bastianich,
merito,
Nati per ballare UK,
Peter Sloterdijk,
prestazione,
talent,
televisione,
X-Factor
sabato 9 novembre 2013
Perché non li lasciamo riposare i nostri giovani "sdraiati"?
L’immagine dei giovani, quella che “gira”, l’immagine pubblica, spesso fabbricata dai cosiddetti influenzatori ma anche dagli “esperti”, è desolantemente falsa. Non tanto nella mera descrizione quanto nell’implicito giudizio che l’accompagna.
Questi giovani: indolenti, debosciati, vulnerabili, insoddisfatti, intolleranti ad ogni minima frustrazione, violenti o succubi, privi di norma, deboli, dediti ad ogni tipo di dipendenza, “sdraiati”.
Se ne possono contare tante. Il soggetto giovane è sempre stato un bersaglio ghiotto per la morale “adulta”, dai tempi di Seneca, e anche prima. Ma mai come oggi assistiamo ad un florilegio di rappresentazioni giudicanti, come se improvvisamente la gioventù fosse diventata irreparabilmente malata, disperata, morbosamente intrattabile.
Trovo tutto questo desolante. Non certo la gioventù, quanto l’immaginario che la concerne, prodotto dagli adulti, spesso adulti totalmente smemorati della loro stessa giovinezza. Oppure adulti del tutto incapaci di immedesimarsi in quell’età straordinaria e complessa.
Qui non voglio presentificare la bellezza della gioventù, Paul Nizan o non Paul Nizan, della quale già altre volte ho fatto l’elogio, un po’ controcorrente.
Qui mi interessano proprio gli adulti. I promotori della grande campagna interventista nei confronti dei giovani, quelli che da ogni dove incitano all’ascolto, al dialogo, alla presenza, al sostegno, al presidio, alla sorveglianza…prima che questi giovani non compiano qualche sproposito, con la droga, la malavita, la prostituzione e tutto il peggio che si possa immaginare.
Questi giovani che vogliono “godere tutto e subito”, godere sempre, ommioddio!
Questi giovani, come dice Michele Serra, ultimo arrivato nella schiera degli immemori moralisti, che “dormono” o stanno “sdraiati” sui divani con i loro Iphone e Ipad mentre i genitori lavorano. Accorruomo!
E’ bizzarro. Così come è invece rivoltante, questo è l’effetto che mi fa- ascoltare lo scandalo nelle voci di chi scopre che anche le ragazze delle famiglie “bene” –e quanto lo sottolineano quel “bene” – si prostituiscono. Fino a che a prostituirsi erano le o i ragazzi “male” non c’era così tanto allarme però. Forse non erano abbastanza all’erta quando molti centri del nostro sud erano, non molti decenni or sono, una meta di turismo sessuale per pedofili… (come oggi lo sono la Tailandia o certe località africane).
Certo, che la prostituzione diventi una “scelta”, anziché una necessità, magari per comprarsi una borsa o un paio di occhiali, fa scalpore. Come se tutti questi oggetti di cui i giovani appaiono tanto “dipendenti” non fossero propagandati in maniera furibonda per “far girare la nostra economia”! E come faremmo a ritrovare la famosa “crescita” senza questa mostruosa coazione all’acquisto?
Ma non voglio cadere anch’io nel moralismo, per carità. Lo vogliamo tutti il nostro “benessere”!
Eppure.
Ma che cosa vogliono questi neoiscritti all’imperituro caravanserraglio della nostalgìa? Saranno almeno cinquant’anni che la famiglia autoritaria è scomparsa, sebbene progressivamente. Con il suo rigore, con i figli che tacciono a tavola e che sgobbano silenziosi e chini nelle loro stanze preparandosi all’indomani. E grazieaddio!
Forse che quella era una buona famiglia, quella dove i figli tacevano e subivano, dove si allineavano e si adattavano al destino prescrittogli il più delle volte dagli altri?
Curioso. Eppure molti di quelli che oggi imperversano con il loro neonato moralismo, i nuovi padri e le nuove madri scandalizzati dai giovani, non sono gli stessi che spinellavano allegramente negli anni 60 e 70, che debosciavano in giro per l’Europa, che cantavano con i Beatles e i Rolling Stones di libertà sessuali, di liberazione dal lavoro e altre scandalose utopie sociali di questo tipo?
Forse no. Forse loro non se ne stavano sdraiati ad ascoltare la musica o a leggere libri sui divani. Loro accudivano la casa, andavano a fare la spesa e custodivano i fratelli minori con proba dedizione. Loro andavano a scuola e silenziosi sopportavano tutto, anche l’insolenza insipiente di tanti insegnanti, perché ben persuasi che dovevano soggiacere a quella mortificazione per diventare domani i seri professionisti di cui la società abbisognava per gonfiare i forzieri di banchieri e grandi imprese.
Forse erano parte di quella maggioranza silenziosa che non prendeva posizione su nulla (me li ricordo) tranne che sull’esigenza di lasciar studiare chi voleva studiare, ché dovevano mettere su presto famiglia e andare a lavorare, per fare progredire “questa nostra società”. Tutori già allora dell’ordine e della pace sociale, quella su cui campano e si ingrassano sempre gli stessi, peraltro. E che magari poi anche loro sono trionfalmente divenuti, grassi e rifatti, con buona pace degli altri che restano indietro, magari a sbrigargli, ubbidientemente, le faccende domestiche.
Oggi gli unici disposti a cooperare, a stare zitti e supini, anche nelle squadre di calcio, sono i poveri che arrivano dai paesi della povertà. Loro che si prostituiscono per pochi centesimi, loro che fanno i lavori umili, loro che ancora hanno padri e madri che li prendono a calci quando disubbidiscono. Loro figli di qualche cultura patriarcale ancora in piedi, per il bene nostro e della nostra santa ipocrisia.
Non ho alcuna nostalgia della cultura patriarcale, che peraltro è ancora bene inscritta nelle nostre mete sociali, nel nostro capitalismo distruttivo, nel DNA strutturale delle nostre scuole e dei nostri ospedali. Se i nostri ragazzi sono un po’ digiuni di patriarcato e sperimentano un poco la loro libertà, fosse anche quella di godere quei simulacri fabbricati dai loro adulti, beh, se fosse così, sarebbe già qualcosa.
Ma non è così. Nessun autentico godimento. Nessuna vera libertà. Solo un’ultima penosa moratoria prima di entrare nel terrificante mondo del lavoro, la grande e unica vera chiesa della nostra vita inginocchiata davanti al dio denaro. Fruiscono, loro figli privilegiati dei paesi dove la ricchezza del mondo si è concentrata a spese degli altri, di una pausa prima di entrare nell’ingranaggio, come lo chiamava Giorgio Gaber. Quello che trita tutti, specie quelli che poi tranciano giudizi immemori e ingiusti sui giovani.
E infine mi si consenta una considerazione più generale, direi addirittura esistenziale. I genitori si lamentano dei figli, del fatto che sono diversi da come dovrebbero essere, disubbidienti, pigri, debosciati. I genitori si lamentano che i figli non restituiscono loro l’amore che gli hanno donato…
L’amore che gli hanno donato…sarebbe interessante indagare caso per caso sulla natura e la qualità di questo amore, ma comunque.
Attenzione. Questo poteva ancora avere un qualche senso quando esisteva una società che interpretava i figli come un “dono del Signore” (o una maledizione), qualcosa che arriva, un’ineluttabilità, e che quindi viveva i figli, nella totale inconsapevolezza profonda di cosa si trattasse, come un dono e come un fardello. Ma oggi, almeno qui da noi, non è più davvero così. I figli sono il frutto di una scelta deliberata, volontaria, consapevole.
Fare un figlio è una scelta enorme, forse varrebbe la pena di ricordarlo agli immemori.
Mettere al mondo, questo mondo, qualcuno, non è un fatto banale. Per quanto mi riguarda non sono del tutto sicuro che risponderei sì alla domanda se avrei voluto essere messo al mondo.
La vita non è uno scherzo. Lasciamo queste favole ai cattolici. Vivere è anzitutto una faticaccia tremenda, un viaggio senza ritorno tra migliaia di ostacoli e di brutture, comunque vada.
Se uno mette al mondo un figlio io credo che debba fare di tutto per farsi perdonare, per desiderare che il proprio figlio viva al meglio possibile, perché sia sottoposto il meno possibile alle ferite e alla soggiogazione delle infinite prove che comunque dovrà passare.
Oppure gli è tutto dovuto (al genitore, e mi si perdoni l’ironìa)? I figli sono spesso definiti quelli del tutto-e-subito, del tutto-è-dovuto. E forse no? Devono aspettare? Fino a quando? Fino a quando diventeranno grandi e saranno stritolati da qualche lavoro ben ben alienato come quello che fanno la maggior parte dei loro genitori, tranne un pugno di privilegiati? Devono forse aspettare di diventare vecchi e malati (non a caso, secondo molte statistiche, l’età più felice della vita, quando trascorsa relativamente sani, forse perché finalmente si è liberi dai gioghi, quelli che ci autoprescriviamo continuamente: scuola, lavoro, famiglia ecc ecc.).
Credo siano interrogativi seri, che possano un poco almeno inquietare la nostra sicumera, quella di chi crede di sapere cosa vada bene per i “ragazzi” e le “ragazze”.
Per l’intanto, se li trovate sul divano, con l’Iphone, svogliati e assonnati, se fossi in voi mi assicurerei che siano divani comodi, che abbiano una coperta morbida. E li lascerei in pace, fino a che è possibile. Perché comunque, anche per merito vostro, non sarà a lungo così.
Etichette:
"sdraiati",
ascolto,
dialogo,
esperti,
famiglia patriarcale,
figli,
genitori,
giovani,
Michele Serra,
sorveglianza
giovedì 17 ottobre 2013
Psicologizzazione o politica dell'educazione?

E’ di tutta evidenza che l’opinione sull’educazione è ormai totalmente delegata agli psicologi, con una nutrita rappresentanza di psicoanalisti (il che è di per sé bizzarro, visto le cattive acque in cui questo sapere ha sempre avuto fama di versare, dal punto di vista scientifico…).
Gli psicologi imperversano, dall’alto delle loro poltrone e dei loro studi clinici, diagnosticando, affabulando, prescrivendo. Il transfert dallo studio o dal centro analitico alla scuola, ai campi gioco e alle famiglie è globale e imperterrito. Veri e propri guru freudiani della sana educazione ci propinano le loro ricette a spron battuto.
La litanìa è nota: scomparsa (o evaporazione, nei più raffinati) del padre, legami duali con la madre o il materno, narcisismo, fragilità, vulnerabilità, disturbi e angosce, intolleranza alla frustrazione ecc. ecc.
I bambini e i ragazzi del nostro tempo sono figli della crisi della società patriarcale, incapaci di affermarsi e di spezzare il legame con gli affetti primari, deboli, insicuri e angosciati. Naturalmente, una vaga nostalgìa dei tempi passati si avverte :purtroppo le grandi isterìe e il masochismo sembrano finiti in soffitta per lasciare il posto alle sindromi identitarie e al “godimento” generalizzato con tutto ciò che ne consegue (debosciamento, violenza, disperazione). E tuttavia raramente si prescrive il ritorno all’autoritarismo paterno. Si raccomanda piuttosto una via di elaborazione intermedia, fatta di guida paziente, di dialogo e di rinascita comune di padri e figli all’insegna di una nuova alleanza.
Tutto ciò, non lo nego, non è privo di suggestione, per quanto queste analisi piene di generalizzazioni indebite appaiono poco aderenti alla molteplicità e alle singolarità.
Ma è anche facile capire perché godano di tanto credito e siano tanto amate da chi desidera influenzare l’opinione pubblica.
In esse, curiosamente, non compare mai alcun riferimento ad altro che non sia appunto la relazione umana, e in particolare la relazione famigliare, più o meno trasferita altrove, e responsabile di tutto. Nessun accenno alle strutture profonde dell’educazione, ai suoi spazi e ai suoi tempi, ai suoi fini ideologici, alle sue compromissioni politiche. Rari accenni alle grandi trasformazioni sociali, che alla fine sembrano esse stesse il risultato delle trasformazioni famigliari, e non l’inverso. Nessun accenno a quello che Foucault definiva dispositivo di potere, al reticolo di discorsi, di pratiche e di pressioni cui i bambini e i ragazzi sono sottoposti dalla loro precocissima presa in carico dalle istituzioni (che francamente rendono piuttosto esiguo il ruolo delle famiglie).
Si continua, con una retorica sconsolante, a sottolineare quanto il patriarcato sia in crisi a partire dalle sindromi identitarie dei giovani quando il nostro mondo e non solo più il nostro appare se possibile ancora più scatenato e feroce che mai nel suo impeto distruttivo, nella sua competizione irrefrenabile, nel primato di un principio di prestazione (tipicamente maschile e paterno, o fallico se si preferisce) che, con l’elogio unilaterale della meritocrazia, dell’eccellenza, e del profitto che si può ricavare dai “cervelli” più o meno in fuga, mai sembra aver goduto di tanta salute e consenso.
Ma no, i nostri bambini non sono figli soprattutto di tutto questo, di una società dove gli adulti sono come pescecani addosso ai quali abbiano gettato un pezzo di carne sanguinolenta, dove tutti sono centrati solo sul proprio successo personale, sulla propria salute personale, sulla propria salvezza personale, in barba a qualsiasi principio comune o “matristico”, per dirla con un linguaggio vagamente antropologico. No, il problema è la scomparsa dei padri.
Mi chiedo che cosa davvero vedano nel chiuso dei loro studi pagatissimi e aristocraticissimi questi professionisti dell’interpretazione. Certo, vedono i rampolli delle famiglie danarose con figli o figlie bulimici o anoressici, in preda al tentativo di sfuggire all’orrore per le proprie case dove padri filibustieri e madri alcolizzate (e viceversa) tentano a turno di ignorare la fatica di esistere dei figli che hanno messo al mondo. Oppure vedono giovani in preda al disturbo del deficit dell’attenzione per una scuola che tutto fa, fuori che tentare anche solo un poco di interessarli e coinvolgerli intorno a qualcosa che davvero abbia a che fare con loro.
Vedono male. Vedono poco. E seminano il dubbio che la colpa di tutto sia nelle relazioni affettive, come se ne esistessero ancora.
Forse occorrerebbe uno sguardo più politico, più smaliziato, capace di leggere la realtà su più piani, come per esempio faceva un filosofo “politico” in un celebre libretto che si intitolava “Educazione” ormai molti anni fa,Fulvio Papi, o Riccardo Massa, un pedagogista che certo non si faceva sedurre dallo psicologismo arrembante. Magari partendo dai piani più sfuggenti, come quello sì fortemente simbolico della distribuzione delle ricchezze, delle classi che, ahimè, ci sono ancora, anche se non hanno più lo stesso profilo di cento anni fa, dei dispositivi di potere, delle trame della merce, del denaro, del profitto, capaci di sagomare i nostri destini ben più di quanto non facciano nella loro frenesìa impotente i nostri poveri genitori.
Questa non è una società senza padri, è una società in cui la paternità si è tradotta nell’astratta ferocia dell’unico vero dio sopravvissuto, il denaro, è la società del profitto e dello scandalo di una competizione globale dove a soccombere sono tutti, tutti i deboli, cioè quasi tutti in fin dei conti, piccoli e grandi, dove non c’è pietà per nessuno, non c’è amore per nessuno, non c’è rispetto per nessuno e nessuna cosa. Valori questi ultimi che forse rinviano simbolicamente alle figure anche del padre e della madre, ma che soprattutto rinviano alla scomparsa di ogni tutela, ogni cura, ogni prossimità, ogni intimità, il che significa scomparsa di dimensioni dell’esperienza notturne, femminili, quelle sì, di cui non si sente neppure più implorare il bisogno, tanto appaiono impossibili e veramente interdette.
Mentre a “godere”, a godere sfrenatamente, sono sempre quel pugno di soliti, un pugno di privilegiati, che però tutti quanti (e confessiamolo!), a caccia di successo, si sogna più o meno smaccatamente di arrivare ad essere (e qualcuno ce la fa anche!).
Le scuole fanno il loro lavoro di sempre: rendere docili i corpi per un sistema pronto a stritolarli, con i suoi bravi insegnanti, pieni di buone intenzioni, di valori umani ma del tutto impotenti di fronte alle leggi dell’economia, quelle che continuano a sagomare il tessuto delle procedure che davvero contano, nelle scuole, al di là di ogni pia buona intenzione: gli esami, le interrogazioni, i voti, le schede, l’apparato enciclopedico e astratto dei saperi, il primato dei cervelli, l’immobilizzazione dei corpi, l’anestesia degli affetti, l’espulsione di ogni dimensione poetica, gratuita, dissipativa, perfino semplicemente interpretativa. Più che mai oggi scuole e università, ben oltre l’assenza o l’evaporazione dei padri, sono il luogo dove vige l’unica legge che governa tutte le autentiche politiche della formazione: quella che il vecchio Marx, e non me ne si voglia se oso citarlo ancora (sì lo so è morto ma allora anche Freud abbiate pazienza), definiva “accumulazione illimitata di capitale” (oggi noi, eufemisticamente, la chiamiamo “crescita”).
Etichette:
accumulazione illimitata di capitale,
crescita,
educazione,
evaporazione del padre,
godimento,
padre,
psicoanalisi,
psicologia,
psicologizzazione
sabato 12 ottobre 2013
Basta con il trito rito della haute culture!
A C.T., intellettuale di strada incontrato nella mia lontana adolescenza
Come è estenuante il balletto della cultura, sempre così prevedibile, così aristocratico, così appartato! La pletora di conferenze, convegni, seminari, workshop, come si chiamano ora, è diventata incontenibile e, al tempo stesso, nel suo moto d’inflazione rovinosa, più che mai separata, vuota e malsana.
Un piccolo universo di esseri umani compiaciuti (e certo lo so, anch’io lo sono e lo sono stato ahimè) e persuasi di dominare il caos, che si raduna in luoghi invisibili a perpetuare rituali a dir poco logori e inservibili. Persone che gareggiano, lontani da tutto, a misurare chi è in grado di produrre il maggior numero di riferimenti difficili oppure semplicemente che si sfidano a farcire la propria prosa delle connessioni più vertiginose e improbabili. Occasioni dalle quali, il malcapitato che non appartenga al ristrettissimo circolo degli iniziati, può solo recedere confuso e mortificato.
Tutto questo non è davvero nuovo ma la misura della sua diffusione, anche esibita dalle molte vesti che essa assume nella rete, la rende oscenamente invasiva (quanto deludente).
Quando finiremo di abusare della conoscenza per farne un uso esclusivamente onanistico? Quando troveremo (di nuovo, perché talora qualcuno ci ha provato) il coraggio per promuovere solo opere davvero esplosive e degne di impatto verso un pubblico “in opera” e non “in vitro”, che sia altro dagli specialisti e rivolto a loro quando abbiano assunto la forma idonea a incontrarlo, sollecitarlo, inquietarlo?
Sia chiaro, le intenzioni buone, l’operosità emerita, la qualità eccelsa delle materie e delle elocuzioni, restano talora fatti evidenti, pur nel loro nascondimento.
E tuttavia trovo non sia più sopportabile il birignao degli intellettuali che ironizzano e prendono le distanze da tutto ciò che non è il loro peculiare e proprio-ombelicale punto di vista sul mondo. Non è più sopportabile la spocchia, lo snobismo, il cacofonismo delle loro loquele aristocratiche e impraticabili. I derridiani, i lacaniani, i deleuziani, i post e gli alter, gli psico e gli antro, i neo e i wu e i tiq e i qun.
E’ da quando mi ricordo che queste congreghe, non più popolari delle logge massoniche, celebrano le loro messe, senza alcuna convivialità per altro, al ritmo funereo della glossa e dell’ipercitazione. Capisco che la flemma pachidermica e l’arguzia poststrutturalista necessiti di spazi stretti e di pubblici eletti, nonché di una buona dose di autopunizione. E tuttavia mi chiedo se non si avverta l’esigenza di uscire all’aperto, di mettere corpo nei discorsi, di depaludare le prose e di sporcarsi in operazioni forti, finalmente visibili e sensibili. E non penso certo ai festival, marketing pur sempre recintati, buoni per turisti del sapere e lettori debosciati. Se non sia di nuovo il momento di fare cultura con un martello migliore, più rumoroso, meno autoriferito.
Vorrei filosofi neokinici che si ostentino alla folla, vorrei dei Savonarola, non certo i miti esercitatori delle miti ascetica stoica o edonistica epicurea. Vorrei sentir tuonare nei treni e nelle metropolitane, vorrei carri di affabulatori feroci che impediscano il traffico e sfidino il flusso frenetico delle merci. Non miserabili raduni di commilitoni sparuti nei retrobottega di librerie irreperibili anche sulle mappe più fini.
Vorrei immolazioni e orazioni, pubblica denuncia non via internet ma nelle strade, caravanserragli di un sapere detto e fatto su misura, nella forma dei luoghi, siano esse piazze, cortili, boschi o spiagge. Il filosofo che soppianta il dj in discoteca, sommergendo gli astanti con il verbo infiammato di Nietzsche o le poesie di Celan (magari con una musica autenticamente hard-heavy-metal). Vorrei sentire gridare le poesie di Pasolini o le insolenze di Artaud nei mezzanini della metropolitana, davanti alle caserme di polizia, ai caselli della autostrade, nei piazzali della grande logistica.
Vorrei vedere i filosofini, i critici letterari, gli psicantropi, armarsi di pennelli e di vernici e riprovare a scrivere sui muri le parole che scambiano tra loro al mercatino della vanità.
Vorrei sentire in permanenza voci forti e irriducibili scatenare la prosa antica e quella del grande teatro dell’assurdo davanti ai palazzi del potere, nelle piazze gremite, nei concerti di musica rock (qualche anno or sono le le lezioni in piazza ne furono un timido avamposto).
Se non altro, renderanno più forte la loro voce, più affilate e precise le loro parole, più soda e scura la propria carne, esposti alle intemperie e agli insulti ma anche alle ovazioni e all’abbraccio di qualcuno improvvisamente rinsavito, rinato, guarito!
E a chi crede alla scorciatoia dei magna media, delle televisioni e dei giornali, sappia che di lì il suo sapere ritorna letame ma letame sfatto, avvelenato e defunto. Di lì, dallo spettacolo massacrato dalla pubblicità, esce solo la morte, la Morte anzi, con la m maisucola, dalla quale non si torna indietro.
Dei seminari, delle conferenze, dei convegni dai quali mai è scaturito nulla, non si può più neanche sentire parlare. Occorre che chi sa, se sa davvero (e non fingo di non sapere che il sapere, per farsi, deve pure avere fermentato in qualche tiepido alambicco), faccia sapere, brandisca il suo sapere come arma, in giro per il mondo, all’aperto, non più il godemiché su misura per le agonìe dei “giusti” in qualche club privé.
Etichette:
C.T.,
convegni,
intellettuali,
Savonarola,
seminari,
separazione
venerdì 13 settembre 2013
Ancora su questa maledetta faccenda del desiderio a scuola
Non fosse che mi hanno intervistato (bontà loro) su questo argomento, di recente, avrei continuato a riposare per un po’ lontano dall’ignavia e dalla superficialità che regna su questa materia tanto imbarazzante. Ma le molto più imbarazzanti banalità che si allineano continuamente sull’argomento, mi provocano a scrivere ancora qualcosa, di breve, per ora, non foss’altro per meditare per conto mio sul problema.
L’inquietudine che circola sul caso di Saluzzo (insegnante che aveva rapporti sessuali, con sue allieve, di cui è ancora da dimostrare l’abuso, ma si vedrà), dimostra che questo è un tema sotto tiro perenne e attentissima sorveglianza, un tema “sensibile”, di cui si capisce poco, tranne forse l’evidenza della sua incoercibilità.
Si continua a ritenere, probabilmente con una certa ipocrisìa, che il desiderio sia un fattore del tutto componibile con le esigenze dell’ordine e della gerarchia. Ma questo è di per sé, con tutta evidenza, profondamente falso. Il desiderio non funziona così, se tale è. Certo, per molti, a un certo punto -saranno i cosiddetti “adulti” di cui parlano con eguale saccente miopìa scientifica i cosiddetti “giornalisti” (gente al soldo della norma, ovviamente) o gli psicoanalisti (pure loro stipendiati dalla norma)-, non è un problema tenere a freno il famoso destriero del Fedro. Usarlo addirittura. Certo.
Ma forse occorrerebbe finirla con questa pantomima. Nel corso di tutta la storia l’esercizio educativo si è accompagnato con il desiderio e anche la sessualità. Non voglio neppure ricapitolare per sommi capi una storia lunga millenni, fin troppo nota, dai rapporti di precettorato antichi, dalle ginnastiche doriche alla formazione ionica, alla copulazione sistematica nei collegi e nelle comunità anche religiose, ben vive e vegete anche ai nostri giorni, fino alla sessualità scatenata di tante scuole e scuolette contemporanee. Il rapporto educativo, se tale, è intriso d’eros, (desiderio e sessualità) appunto, sotto mille forme. Poi lo si può prosciugare e decontaminare, come ha tentato di fare la scuola laica, prosciugando però al tempo stesso ogni traccia di desiderio anche dal rapporto con il sapere (che è inevitabilmente segnato dalla traccia del vissuto di chi ce lo fa conoscere), e allora si ha un sapere distillato (nel senso dell’acqua distillata), insapore, incontaminato e inodore, del tutto privo di vita (come quello che propugnano gli ultimi e più micidiali epigoni della combriccola: i promotori dell’ e-learning).
Si dice, neanche in maniera troppo velata: la colpa è nella seduzione (Veladiano, Repubblica). Occorre contenere la seduzione. E’ un’affermazione che ha dell’incredibile. Non foss’altro che viviamo nell’epoca della seduzione scatenata, quella perniciosissima e priva di corpo della mediocrazia (dei media e del mediocre), che ad ogni angolo ammicca e ci lusinga con le sue profferte sempre stracariche di allusioni sessuali (nei confronti delle quali, beninteso, non c’è nulla da scandalizzarsi: è da sempre che le cose funzionano così: non è sempre stata comunque la bellezza a richiamare la fede/fiducia delle persone?).
Non foss’altro poi che tutti noi insegnanti dobbiamo sempre più lusingare il pupo pena la squalifica da tutte le classifiche di accettabilità delle nostre proposte educative, ben valutate da plotoni di studenti e studentesse vogliosi finalmente di rendere la pariglia a chi da sempre e senza alcuna temperanza ha valutato loro…
Ma la cosa è poi ancora più assurda proprio in tanto e in quanto non è concepibile alcun appello al sapere che non passi attraverso la seduzione. Seduzione, condurre verso, verso di sé, certo, beninteso, anche. Chi affascina, intorno al sapere, non può, in virtù di non si capisce bene quale torsione psicofisica, assentarsi dalla relazione che instaura comunicando la passione verso l’oggetto. Le due cose fanno tutt’uno. Amo la materia e chi me la fa conoscere, perché la amo proprio in virtù del fatto che qualcuno mi ha, con il fascino che emana anzitutto da lui, soggiogato. E’ inscindibile. Dopo di che, certo, non è detto che l’eros debba essere agito.
Nella storia esistono però infiniti rapporti, nati all’insegna dell’ammaestramento, che si sono tramutati in amore anche reale, che non sempre sono apparsi distruttivi, corruttivi o abusanti (almeno da Eracle e Iolao). E del resto chi è in grado di stabilire con certezza quando si tratta di abuso?
I ragazzi sono spesso costretti o indotti persuasivamente ad accusare i loro sventrapapere o i loro iniziatori, se si preferisce un linguaggio più allusivo. Ma chi conosce il teatro profondo dell’educazione sa che le cose raramente sono così chiare e che chi seduce è spesso il sedotto e che questa embricazione è anch’essa, nella maggioranza dei casi, ineliminabile. E non mi si parli di minori e maggiori. I minori, minori certo entro certi limiti ovviamente (non parliamo propriamente di infanti: il loro eros elfico e selvatico presenta ben altra texture e necessita di ben altra elaborazione), maneggiano l’arte poliedrica della seduzione spesso meglio di chi da tempo si è assuefatto al grigiore delle routine e delle sublimazioni (tanto amate dai nostri sordidi asceti: di ciascuno di essi vorrei conoscere il curriculum personale e scoprire dove e quando ha smesso, se ha smesso davvero, di desiderare la seduzione e di essere sedotto o seduttore).
Insomma: occorre dirsi la verità, e poi, a partire dalla verità, e cioè dalla necessità organica del desiderio nell’esperienza vitale e integra dell’educazione, come delle molte altre esperienze autentiche dell’esistenza, cercare di capire cosa può essere ammesso e cosa meno, e soprattutto come. Occorre fare i conti con i corpi, con i desideri, con la bellezza, con il sapere come sapore, profumo, materia seducente e non scarnificata architettura di crisalidi vuote come certi libri e certi presunti sapienti. Occorre saper leggere l’eros nelle sue infinite sfumature, nei modi infiniti con cui può essere diffuso e integrato nell’esperienza educativa anche senza tramutarsi in diretta esperienza sessuale. Ma anche come la sessualità può concorrere a umidificare e animare la scena educativa, nelle molte forme che essa può assumere. I grandi itinerari spirituali conoscono bene l’implicazione sessuale di ogni autentica via di conoscenza. Perché non la debbono conoscere i nostri impresentabili programmatori scolastici?
Quando finalmente il sapere sessuato, e la sessualità stessa, diverranno argomento di condivisione -non dominato dalle preoccupazioni igienico-sanitarie vili e fraudolente di medici e psichiatri assoldati dalla moralina diffusa-, ma proprio di sapere, nel senso pieno del termine, ricco di storia, di immagine, di pratiche, di esercizio?
Probabilmente quando si leveranno dai cabasisi tutti questi moralizzatori da quattro soldi, stipendiati per dire ovvietà del tutto vacue quanto inutili. Quando a fare, insieme, l’esperienza del sapere saranno uomini e donne viventi, sofferti, iniziati all’autentico desiderio di conoscere, che necessita di un magistero che francamente con il guazzabuglio indegno di questa nostra scuola poco ha a che fare! E che finalmente potranno incontrare bambini e ragazzi ancora vivi, nel fiore dei loro anni, pronti a non derubarli del loro diritto ad essere e desiderare e fare e esprimere e sperimentare ma che sapranno corrisponderli davvero, senza paura di nulla.
Del resto parliamoci chiaro. Senza eros -l’ultimo segnale di vita nella rampante macchinizzazione totale (e non certo quella delle macchine desideranti!)-, per noi è davvero finita.
Etichette:
abuso,
allievo,
desiderio,
insegnante,
scuola,
sesso,
sessualità
domenica 14 luglio 2013
Piccolo elogio dei piaceri
Non si tratta più di interpretare il mondo, ma di viverlo, anzi di copularlo…
Copulare il mondo: aderire corpo a corpo, pelle a pelle, umidità a umidità, sfregarsi e carezzare. La vita come manifestazione fisica del mondo, contorno delle cose, della natura, dei luoghi e della materia, in cerca di armonia. Il simile ama il simile, la mano cerca il piacere del contatto con la pelle del mondo, morbidezza e flessuosità che si rispecchiano nelle materie morbide e flessuose, nelle tinture corporee della sabbia, dei legni, dei metalli ambrati. L’inumidimento e il bagno, il giacere e il penetrare, l’accogliere e il trattenere. Lottare con le asperità fino a indebolirne la resistenza, lasciarsene impregnare.
Lo sguardo che cerca requie nell’ombra e l’eccitazione nell’immenso. Che fruga gli interstizi del bosco e si acquieta nelle radure. Sguardo in cerca di calma ma anche di tessiture molteplici, di iridescenze, di vertigini opaline. L’orecchio che vuole essere riempito dalla risacca marina, dal gocciolare invernale della neve che si scioglie. Che è invaso dal vento tra gli alberi e che vibra con le palpitazioni e i pulviscoli sonori della musica. Aderire al corpo degli esseri, pietre, prati, rami, pavimenti in legno, in tessuto, tappeti, letti di piume e di gomma di lattice. Il mondo come corpo femminile, misterioso e tondeggiante, seducente e provvisto di aperture umide, cosparso di miele, mercuriale e sulfureo, intensamente profumato, saporito. Corpo maschile, teso e ripido, irsuto e combattivo, agitato e eretto, capace di strette violente e di lunghe selvagge penetrazioni.
Percussione del corpo sul tamburo della terra, frenesia e eruzione di piacere. Il terreno come letto dove giocare, lottare, amare, dormire. Come rifugio, come nido, come culla. I piaceri della superficie, esterni, solari, asciutti, nitidi, di vista e di contatto, accurati, sorvegliati, padroneggiati. I piaceri del profondo, umidi, notturni, di odore e di sapore, vulnerabili e diffusi, lenti e abbandonati, imperscrutabili.
La farmacia del vivere contempla infinite soluzioni. La controeducazione non predilige solo una parte del caleidoscopico mondo dei piaceri. Il suo perno di gravitazione resta l’esultanza mista e sfarfallante, la variazione e la ciclicità in affinamento. Ogni manìa, seguendo Fourier, va assecondata, e la mensa, per non dimenticare Sade, ha più di seicento portate. Dunque sia affermata l’erotica solare ma non meno che ad essa si avvicendi l’erotica notturna, alla danza dionisiaca si alterni la meditatio contemplante e la vasca di fluttazione onirica.
E dunque piaceri della superficie, solcare le pelli, le pagine, i crinali salati di spiagge e il vello ispido delle pinete. Scivolare sui corpi, aderirvi, massaggiarli, corpo del sapere, corpi eccitati e inumiditi dal piacere. Piacere solare dello sforzo, dell’esposizione, della voce proiettata nello spazio. Piacere del movimento, della danza, della lotta, del gesto condotto al vertice della sua eleganza. Piacere del contatto, dell’attrito, dell’urto. Piaceri dell’intreccio, del viluppo, del rotolamento. Piaceri dello sprofondamento, dell’accensione di un’accoglienza ipersensibile, modulazione lenta di posizioni per intercettare l’infrasonico e l’ultravisibile.
Piacere del sonno, dell’immersione fantastica, della contemplazione a occhi chiusi. Piaceri di pura regressione, dell’oscurità assoluta, del tuffo silenzioso in ambienti impermeabili al rumore e alla luce. Piacere del reinfetamento. Piacere di sostare, di arrendersi, di piegarsi pigramente nell’ombra.
Piaceri della lettura e della visione, visione di immagini statiche, in movimento, piacere del cinema, delle fotografie, piacere del foglio scritto. Piacere del cibo, della bevanda, piacere dell’ebbrezza nelle sue gradazioni molteplici, per elisir, per sostanza, per abissi corporei.
Piaceri e ancora piaceri…
martedì 25 giugno 2013
Non fare
Sempre più il non fare mi pare l’unica via di uscita. Non solo come pratica terapeutica antica mirante a una qualche forma di equilibrio psicospirituale. Quanto soprattutto come reazione, come gesto sovversivo nel tempo dell’affaccendamento totale.
Davanti all’agitazione convulsa che muove gli umani in ogni dove nella più radicale confusione e nell’oblio evidente di un qualche straccio di senso che ne orienti l’agitarsi, sento l’impulso al non fare come la risposta necessaria e ineludibile. Opporre il non fare, l’indifferenza alla domanda di agire, lo stare fermi allo sbattere di farfalle impazzite attorno ad una fonte di luce artificiale che non ha nulla di buono da regalare, se non la morte.
Mentre tutto ci chiede di fare qualcosa, sempre, costantemente, non solo gli attori esterni, ben noti, del nostro assoggettamento ad un agire vano, ma anche il tumultuoso esercito interno dei sostenitori del nostro successo professionale, sociale, commerciale. Il più pericoloso, come è noto, quest’ ultimo, camuffato da nobili voci interiori che ci tempestano rimproverandoci di non fare mai abbastanza, di non riuscire mai a “ottenere” abbastanza, di non essere mai abbastanza “riusciti”, “arrivati”, “compiuti”. Di fronte a questo duplice plotone di gerarchi del nulla, arrembanti fuori e scatenati dentro, più tutto il prossimo che ci incalza con la miseria ossessiva delle infinite preoccupazioni quotidiane, di fronte a tutti questi, con impietosa e algida noncuranza, occorre imparare ad opporre la sovrana negligenza del non fare.
Meravigliosa statura di diserzione che finalmente pacifichi il nostro moto inconsulto, che consenta di pensare ma anche di non pensare e di distillare dalla pazienza dell’attesa un desiderio sufficientemente autentico da essere semplicemente diverso da quelli sovraalimentati dalla corrente ad altissimo voltaggio dell’orgia societaria. Un desiderio che ci faccia trasalire per la sua sorprendente aderenza a qualche traccia di sensibilità davvero radicata nella nostra intimità, sempre che sia da qualche parte sopravvissuta. Ebbene qualcosa del genere non può che nascere dall’assoluta interdizione al fare, a quel fare del tutto eterocondotto anche quando lo si ritenga al servizio della nostra affermazione, e che proprio allora semmai riconosciamo nella sua falsità fatalmente perversa.
Nessun bene, nessun successo, nessuna posta in gioco, solo l’ascolto affinato del desiderio ultimo, ormai quasi inattingibile, che giace da qualche parte in un sottosuolo non più frequentato della nostra vita.
Ai superiori gerarchici che ci scrutano attendendosi qualcosa da noi, ai colleghi, che ci sollecitano alla corsa, alla competizione, o che ci sgambettano e ci ostacolano dando però l’esempio di quanto ci si debba mobilitare per apparire vivi e attivi, ai parenti, alle compagne e ai compagni che ci vogliono in azione, di solito un’azione che serva le loro fantasie o i loro bisogni, a tutto l’esercito dei nostri minacciosi portavoce superegoici, a tutti i luogotenenti del corpo al lavoro e sotto il giogo della fatica, occorre contrapporre il serafico ma splendido atto del non fare.
Atto per sottrazione, atto di purificazione, atto di scomparsa, di assentamento. Atto inetto, inadeguato e inatteso. L’atto più difficile per noi dipendenti dall’affaccendamento, ma tanto più soddisfacente quando lentamente si afferma come avvento del meraviglioso, avvento, nel panorama bonificato finalmente dai flussi frenetici del nulla, di uno o due gesti davvero voluti, di una o due azioni quintessenziate carpite al fondo invisibile nel quale erano rimaste confinate e soffocate dal turbinante divenire del nostro autodafé.
giovedì 16 maggio 2013
I nuovi "untori"

Una nuova barbarie si diffonde nella civiltà contemporanea, una nuova stirpe di untori: i Patologizzatori. Sempre al lavoro, infaticabili, irreprimibili. Devoti alla religione della classificazione e della normalizzazione, nuovi sacerdoti della bonifica di ogni sporgenza, di ogni divergenza, di ogni irriverenza, sono sempre pronti a secernere nuovi nomi per improbabilissime sindromi ma soprattutto a esercitare l’ufficio di scatenare la colpa e di mettere in cura, in pentimento, in redenzione, tutti coloro che sono in qualche modo incappati in una manifestazione di intemperanza o di eccedenza. Foucault ce lo ha spiegato per il dritto e per il rovescio che l’esercizio del potere, della repressione e della marginalizzazione di ogni espressione dell’essere altro sarebbe passato, anzi è ormai passato dalla tortura, dalla sanzione, dall’interdizione, dall’esclusione alla patologizzazione e alla cura. Ma nessuno sembra in grado di difendersi da questo virus contagioso, da questa forma subepiteliale e ormai pervasiva di sorveglianza e di manipolazione continuata e scatenata.
E’ persino troppo facile mettere alla berlina i professionisti più indomiti di questa campagna, i professionisti della medicina, al soldo dell’industria farmaceutica e dell’ipnosi di massa. I nostri cari medici, succubi e complici della sistematica diffusione di paranoia nei confronti del più piccolo disturbo che si manifesti sotto la forma di comportamenti definiti disturbati ma soprattutto disturbanti. Di un tale esercito di poliziotti in càmice, l’exploit più eclatante è indubbiamente quello che ha visto e vede tuttora milioni di bambini esposti all’insolenza della diagnosi di disturbo di iperattività e deficit di attenzione. Un nome che da solo partecipa del delirio di chi l’ha prodotto e che prende di mira tutti quelli che si comportano, specialmente in luoghi di coercizione e di annoiamento sistematico come gli istituti scolastici, con l’unica reazione ragionevole: avere crisi di agitazione e rifiutare qualsiasi invito a chinarsi sopra oggetti il cui interesse è pari a zero.
Eppure qui è in atto una guerra, una guerra terribile, la cui posta è la salute psichica e fisica da un lato di bambini e ragazzi ma anche il loro diritto a esprimere la propria ribellione, la propria singolarità, la propria differenza ora e per sempre. La testimonianza del tutto comprensibile che la diffusione di un tale supposto disturbo offre dell’incredibile fallimento dell’istruzione scolare a farsi prendere sul serio è solo uno degli aspetti che dovrebbe porci in guardia da un complesso reticolo di azioni patologizzanti poste in atto da tutti gli stakeholder di un sistema che tollera sempre meno la particolarità e vorrebbe mettere sotto farmaco (carpendo spropositati guadagni da ciò) tutti i renitenti ancora in circolazione.
Senza ora entrare nella disamina, doverosa per altro (invito a farlo), della diffusione di malattie inesistenti che camuffano tuttavia il proposito di normalizzare il diverso oppure semplicemente di rendere insostenibile il più piccolo disturbo in modo da poterne quanto prima mercificare la cura, appare ben più subdola e preoccupante un’altra genìa di untori e patologizzatori in grande auge: gli psicologi.
Sono essi oggi i più scatenati nel rilevare le disfunzioni dei bambini, dei giovani, ogni qual volta manifestano quel giusto diniego di fronte ai compiti loro prescritti da istituzioni fatiscenti e per nulla più (se mai lo fossero state) credibili e affidabili quali famiglia e scuola. Di fronte a ragazzi svogliati, poco propensi a chinarsi su libri e offerte di educazione palesemente imbarazzanti e impresentabili, oppure che in famiglia appaiono desiderosi solo di negare ogni contributo alla farsa relazionale chiudendosi nei loro rifugi antiatomici per guadagnare uno spicchio d’avventura e di libertà, per quanto simulacrale, nella rete, oppure ancora pronti a buttarsi su qualsiasi dipendenza li possa separare dal brodo insostenibile di padremadre e insegnanti lobotomizzati; ebbene di fronte a ciò, del tutto comprensibile e perfino auspicabile ad un occhio che non voglia il loro male e la loro conformizzazione integrale, ecco levarsi la schiera di psicologi e associati pronti a far sferragliare la consueta chincaglieria di sindromi puberali, di disadattamento, di disturbi narcisistici e altre inusitate diagnosi tutte tese a patologizzare il pupo per renderlo prono ad ogni nuova azione di supplizio terapeutico affinchè ritorni, lobotomizzato a dovere, ai compiti quotidiani con indomito spirito di sacrificio e malleabile passività (come il povero McMurphy in Qualcuno volò sul nido del cuculo.
E’ questa una guerra che deve vedere ogni spirito ancora libero combattere colpo su colpo all’offensiva terrificante dei patologizzatori, delle loro diagnosi, delle loro terapie e del mondo che dietro di loro si profila, puro distillato dell’uniformazione totale. Non permettiamo che si vaccinino i bambini e i ragazzi, che vengano disboscati, igienizzati, candeggiati, insomma educastrati e psicosvuotati dall’esercito dei patologizzatori al servizio del nulla.
Etichette:
bambini,
patologizzazione,
psicologi,
ragazzi,
sindrome di iperattività e deficit di attenzione
lunedì 13 maggio 2013
La verifica dell'istruzione...

Ogni giorno, più o meno, tocca sorbirsi qualche nuovo economista o sociologo al soldo di qualche istituto di ricerca venduto, o giornalista o tecnocrate o funzionario INVALSI delle belle esegesi quantitative, che ci sciorina dati numerici sul fallimento dell’istruzione scolare, con o senza tabelle, sempre con percentuali, diagrammi, comparazioni, insomma tutto il baraccone della arcinota oggettività “scientifica”. Che barba!
Stuoli di verificatori che partono all’attacco delle classi con i loro test, i loro parametri, le loro scale, i loro istogrammi. Aiuto!
Ma che cosa vogliono “verificare” esattamente? L’incorporamento di informazioni, o di competenze, si dice. Ma a che livello, a che stadio di trattenimento, dimenticanza? E poi sono davvero in grado di assicurare che ciò che un giorno sembra acquisito, dopo qualche mese non sia scomparso senza lasciare traccia? E come possono misurare ad esempio la capacità creativa, o quella che l’ultimo umanista Yves Citton chiama “interpretazione inventiva”, cioè la capacità non solo di rispondere a domanda ma di problematizzarla, rifletterla, rimuginarla, rivederla, sondarla, trasformarla, insomma quel lavoro che una qualsiasi intelligenza media non sabotata dall’idiozia quantitativa fa quando qualcosa la interessa?
Ma forse questo è fin troppo raffinato, è davvero un eccesso di presunzione di fronte ai geometri del nulla addizionato al nulla uguale al nulla.
Ciò che a mio giudizio dovrebbe valere, per valutare la qualità dell’istruzione, è proprio tutt’altro, non c’entra nulla con schede, parametri, verifiche e confronti. Non è nell’oggetto, non è oggettivabile. Perché non è lì quello che conta.
Non si tratta di capire se qualcuno ha immagazzinato date di storia e teoremi di matematica, che probabilmente potranno consolidarsi solo a patto che poi vengano riutilizzati in qualche frangente vitale e che invece cadranno nell’oblio se verranno abbandonati.
Si tratta, volendo comprendere la benedetta qualità dell’istruzione, di cogliere ciò che accade nelle aule scolastiche, la temperatura dei processi, l’intensità delle attenzioni, il volume degli appassionamenti, unici indici che possano effettivamente rendere conto di ciò che sta accadendo. Se è in atto una decostruzione/ricostruzione di idee, concetti, immagini, gesti , forze che determinano poi comportamenti, azioni, effetti.
E questo non si può misurare con prove, con test, questo è palpabile non appena si varca la soglia di una classe, di un’aula, di un laboratorio. Lo si percepisce guardando, ascoltando, palpando l’atmosfera. Se c’è intensità, vapori che si innalzano nell’aere, occhi aperti, interesse, mani che cercano, curiosità, attivazione oppure se c’è torpore, distrazione, attesa disperata. Se la qualità del silenzio è ricca o povera, attiva o passiva, se quella del rumore è striata di suoni complessi che ritmano in risonanza o se si avvertono solo lacerazioni, attriti confusi, colpi nel vuoto.
L’unica verifica che possa misurare la qualità dell’attività scolastica è la pura, mera, concentrata attenzione. Sollevando un momento lo sguardo da ciò che sta facendo, un insegnante, si accorge se, in quel momento, c’è intensità, passione, volontà oppure il vuoto pneumatico. Se, quando suona la campanella, scappano indiavolati in cerca di aria oppure si sentono interrotti in qualcosa che vale la pena di essere compiuto.
Dove ci sono gli ingredienti della vita qualcosa sta accadendo, e nella singolarità della carne di ognuno, della sua storia, della sua attitudine speciale darà luogo a conseguenze. Quelle importanti, forse ancora impercettibili, quelle che si stanno incidendo nel profondo, di certo non sono ora misurabili. Quelle che possono essere misurate, nella loro fredda oggettività, sono le più caduche e insignificanti.
Si bandisca una volta per tutte questo baraccone delle prove e si provi invece a edificare un’esperienza del sapere che cerchi nell’intrinseco interesse delle sue proposte e nell’accaloramento appassionato che ne deriva l’unico criterio che la giustifica!
Etichette:
INVALSI,
istruzione,
scuola,
valutazione,
verifica
sabato 13 aprile 2013
Eros d'infanzia - da "Antipedagogie del piacere" (2008)
.jpg)
“Che là soltanto dove tu sei, tutto sia sempre d’ infanzia. Allora tu sei tutto, sei inespugnabile”
(Goethe)
[immagine Meyer-Amden: “ragazzo in piedi a gambe incrociate”]
Il “corpo mitico”, diffuso, inaccessibile, posseduto, elfico e demoniaco del bambino, quel “blocco d’infanzia”, così definito da Deleuze e Guattary proprio per rilevarne il radicamento in un universo indistruttibile sottratto al tempo, un po’ forse come la rêverie d’infanzia di Bachelard, ci viene rivelato in un folgorante saggio di René Schérer sulla pittura di Otto Meyer-Amden. I suoi fanciulli, ritratti in un atmosfera velata e come onirica, per esempio nella Lezione di disegno, del 1920, o come dei veri e propri kouros greci, assurgono a immagini archetipiche, a corpi di luce in cui sembra realizzarsi, nella tessitura intermedia dell’immaginale, la quintessenza irriducibile di un’infanzia perduta. Corpi che “non sono rappresentazioni, ma degli interrogativi, delle offerte. Che ci riguardano” (Schérer, 2002, 110).
Nei loro corpi nudi, resi essenziali e come sottratti ad ogni riconoscibilità fenomenica, ma risorti in una nudità perfetta, si rivela l’indicibile dell’infanzia, qualcosa che mostra ciò che dell’infanzia è tacitato dallo sguardo abitudinario, quel quid che suscita “rapimento e turbamento” al loro cospetto. Di cosa si tratta?
Questi giovinetti liberati dalle loro imperfezioni e guidati da un disegno sapiente alla propria “purezza d’origine”, ci restituiscono probabilmente quella che lo stesso Schérer indica appunto come “infanzia mitica”, forse un’infanzia permanente e inattingibile cui sembra del pari talora rinviare Bachelard ma che l’autore francese dell’ Emilio pervertito e di Un’erotica puerile apparenta piuttosto al piccolo Eco (soprannome di Nepomuk) del Dottor Faust di Thomas Mann o al giovane Basini dei turbamenti torlessiani di Musil. In questi autori sembra respirare l’infanzia “permanente” e irraggiungibile, ed anche in altri: Schèrer fa riferimento anche al giovane Tadzio della Morte a Venezia, sia nella versione viscontiana che in quella originale manniana, e al fanciullo che sembra traspirare dallo sguardo di Clawdia Chauchat, la misteriosa ricoverata di cui Hans Castorp si innamora nella Montagna incantata, quel “Pribislav dagli zigomi kirghisi”, dai capelli corti e dagli occhi grigi che ancora lo fa trasalire.
Ma questa infanzia trasmutata, androgina, transeunte e inevitabilmente compromessa con la morte o meglio la mortalità, non è poi così lontana dalle lolite di Balthus, anche se, per Schérer, “il ragazzo resta il paradigma di questa transizione tra l’organico e l’inorganico in cui il corpo appare sfuggire al suo destino. Dove, per eccellenza, l’astrazione si rende visibile; in lui solo l’evidenza dell’organo virile si allea alla grazia che noi prestiamo alla femminilità” (112-113).
Schérer insiste sull’astrazione del suo nudo, della nudità” celebrata da Meyer-Amden. E’ in virtù di una tale astrazione, “estetica”, che i corpi dei giovani pensionati ritratti dall’artista non vengono appiattiti sul cliché che non è che “il puro prodotto sessuale della coppia”: nudo ridotto a segnale e già indirizzato al destino sociale dell’accoppiamento dove il maschio è assegnato alla donna o il ragazzo alla ragazza. Qui il nudo sfugge alla banalizzazione segnica cui lo condurrebbe l’evidenza di una modernità moralizzatrice e preoccupata soprattutto di rivelare la crescita e la potenzialità sociale e sessuale del soggetto già avviato verso un futuro prescritto. In questo caso, secondo Schérer, ci si assicura l’incontro con uno “choc” liberatorio, provocato dalla nudità astratta, capace essa sola di restituire “intensità alle onde che, del nudo, disegnano i contorni e la superficie: “(…) solo un’astrazione è capace di rendere al nudo la sua luce, l’irraggiamento che da lui promana e che, mentre sollecita tutti i sensi del voyeur, lo rende tuttavia inaccessibile” (111). Nel nudo così cristallizzato, viene mantenuta la “distanza nella prossimità”.
Un nudo che celebra una nascita, ma una nascita inattesa, l’emergenza di un sempre inaccessibile. Il corpo vi si trova prossimo, apparentemente, ma allo stesso tempo infinitamente distante, rapito nella sua trascendenza originaria, e oltreoriginaria in senso simbolico. “La sua prossimità commovente è quella di un altrove” (112). Ecco allora come il nudo così carico di vibrazioni astratte sconfina nell’universo metafisico, incarna una infanzia mitica e sovversiva al contempo, che non si inscrive in alcun progetto parentale o pedagogico e che sembra indicare un elemento ermetico ed essenziale dell’esistere stesso. Il corpo viene presentato dal pittore come “offerta”, come “sacrificio rituale” (118).
Ciò che ci viene esibito è il “corpo glorioso” del fanciullo, proprio in quanto offerto, cioè “portato in avanti e affermato” in tal modo accrescendo enormemente la sua potenza d’essere e d’agire. In questa esposizione compiuta e sradicata al contesto servile da cui è strappata, o meglio evidenziata, il fanciullo rivela il suo carattere istantaneo, la sua fugacità in perfetto equilibrio, che contiene in germe, rendendolo ancor più imprendibile, la morte. Ed è proprio questa morte, d’altro canto, a proteggerlo. L’affioramento effimero di questo corpo sottratto al suo destino storico e convenzionale, assurto ad archetipo, ma pur sempre saturo delle sue componenti erotiche, è un corpo eterno, esente da corruzione in quanto proiettato sempre sul punto della sua scomparsa, della sua estinzione. Meyer-Amden strappa quel momento, in virtù di un trattamento sottrattore e prosciugatore, ma non disincarnante, poiché nelle sue opere, semmai, si dà, come per incanto, l’equilibrio di una saldatura, quella tra corpo fisico e corpo celeste, in una del tutto desiderabile coniunctio oppositorum. E d’altra parte, come suggerisce acutamente l’autore del saggio, “il corpo glorioso dell’infante contiene la morte come punto di fuga, come uscita di soccorso, come scappatoia all’insopportabile che lo circonda e lo misconosce” (120).
Ecco allora che nella riflessione che Schérer conduce a partire dalle immagini incorruttibili di Meyer-Amden, assistiamo alla manifestazione di un’infanzia mitica contrapposta all’infanzia vigilata, sezionata, categorizzata, gerarchizzata e strumentalizzata della cultura dello sviluppo e dell’istruzione sacrificata all’inveramento dell’età adulta. L’infanzia mitica, o il mito dell’infanzia, prendono la forma di una “carne estetizzata, spirituale e angelica” (122). E si distanzia radicalmente dalle prescrizioni famigliari, pedagogiche o igieniche che il dispositivo sociale appresta per il suo approdo alla conformità.
Si tratta, per Schérer, ma anche per ogni pedagogia che non sia orientata semplicemente a farsi serva dei processi di conformazione sociale, e che invece rammenti il suo necessario compito di garanzia del simbolismo d’infanzia -di una pedagogia come pedosofìa (Mottana, 2002)-, di presidio affinché non sia facilmente consentita l’estirpazione dell’infanzia verso un divenire altro da sé, ma che miri a promuovere un divenire-infante, sia come, nella suggestione di Deleuze e Guattari, “divenire-donna, divenire-animale, divenire-pianta, divenire-impercettibile” (Deleuze, Guattary, 2006, 433 sgg.), sia nell’azione di preservare la sua alterità di fedele all’ “Aperto”, come voleva Rilke, alla vita delle stelle e delle piante, ad essere custode di una posizione dell’esserci che non sia ancora stata requisita verso la ragione del dominio, ma che invece perdura nel luogo della solidarietà cosmica, della rëverie cosmica, come la chiamava Bachelard (1972, 188 sgg.), nel luogo dell’origine e dell’indeterminato.
In un altro passaggio della sua opera René Schérer definisce l’infante “inaccessibile”, proprio da questo punto di vista: “l’inaccessibilità dell’infante, la sua esistenza straniera allo stato di pianta, minerale o animale, lungi dall’alienarlo in una obiettivazione pietrificante, è la condizione stessa del suo essere libero” (Schérer, 1978, 63). E’ proprio questo il luogo di un’erotica infantile sottratta alla manipolazione “umanista” che tenta di disciplinarla e di inglobarla.
L’infanzia rimirata, con desiderio, attraverso le figure immaginali di Meyer-Amden, di questi corpi collocati tra il visibile l’invisibile, conduce verso uno spazio radicalmente inattuale, quello del mito. Qui il fanciullo, nel liberare il proprio corpo nudo, si fa emblema di un’insormontabile differenza, effimera, non sacrificata sull’altare di alcuna impresa alienante. Il pittore garantisce il suo corpo contro ogni potere, pur mantenendolo pienamente nell’orbita del desiderio. “Poiché questo corpo è pienamente sensuale, una sensualità derivata tuttavia, non orientata verso l’identificazione sessuale quanto condotta verso multiple metamorfosi. Non essendo concentrata su una sessualità possessiva, attraverso tutta la sua superficie visibile, attraverso tutte le se forze invisibili, esso irradia verso l’universo e i suoi regni molteplici” (Schérer, 2002, 127).
In questo senso “l’adoratore mistico, l’amante feticista sono i soli – e non certo gli ‘specialisti dell’infanzia’, i pedagoghi- a riconoscergli e accordargli la pienezza dei suoi poteri” (ibidem). Poteri di irradiamento, appunto, e di metamorfosi, proteica e diffusa, divenire animale e stella e elemento, farsi nube e acqua, e colore, o forse sarebbe meglio dire tintura, immaginando che il lato qualitativo di questo corpo incandescente possa agire come una tintura alchemica, a fini trasmutativi e guaritori. In tal senso il corpo dell’infante è pura forma, informale, materia pronta a esplodere in tutte le sue infinite potenzialità, indesignabili e imprevedibili, se lasciate alla propria vocazione, alla propria possessione, alla propria daimonìa, come dice Hillman.
Il corpo dell’infante in realtà non ha sottofondi, non ha scantinati. Così ce lo mostra Meyer-Amden: estrovertito, felicemente appagato del proprio esserci del tutto esteriorizzato e gioiosamente impudico. E’ questo il corpo dell’infanzia sottratto a tutte le ipoteche pedagogiche che lo hanno letto, anche psicanaliticamente, come crocevia di desideri inconfessabili. Il corpo dell’infanzia, nella sua alterità interrogante, è invece del tutto “irresponsabile” e pieno, distante anni luce da ogni raffigurazione personalista che di esso si possa dare. E’ solo affidato, anzi devoto, all’ “innocenza” perfetta del suo divenire, come disse Nietzsche. Si tratta dell’infanzia restituita ai suoi recessi demoniaci ed “elfici”, alla sua costitutiva differenza, che riluce tanto nelle immagini di Meyer-Amden quanto nei quadri di Balthus o nella disponibilità senza riserve, nella felicità smisurata e trionfante, così desiderabile proprio perché in appropriabile della piccola Dole de Il mio primo miracolo di Anne Wild e di tanti altri infanti che i mondi immaginali hanno preservato dal disciplinamento tenendoli al sicuro nel riparo intermedio dell’immaginale.
Ma qual è il nucleo del perturbante d’infanzia, o meglio, qual è la cifra del suo specifico erotismo? Nessuno meglio di René Schérer può esprimerla, essendone un cultore e un esegeta ineguagliabile: contrariamente a tutto ciò che la proiezione psicoanalitica (non analizzata?) vi accumula di morboso e di regressivo, l’Eros d’infanzia si rivela anzitutto per la sua invisibilità e sfuggevolezza, come già hanno in parte dimostrato l’archetipizzazione che ne restituiscono Balthus o Meyer-Amden. L’infanzia non è là dove la dipinge la sociologia moderna o peggio la psicologia, più o meno cariche di reperti ricavati dallo scavo dei suoi meandri più oscuri. L’infanzia è estrovertita, non è mai sordida se non nell’occhio di chi ne teme la “dismisura”: “irriducibile, a dispetto di tutto, alla normalizzazione, vi è una dismisura infantile che se la ride della personcina già ‘responsabile’ a cui l’infanzia contemporanea si dovrebbe identificare”(Schérer, 1978, 18). Incatturabile, imprevedibile, l’infanzia, come già un tempo nella lucida visione di Fourier, esibisce il suo Eros non certo nella fissazione a qualche stadio o a qualche pulsione, semmai nella proliferazione disseminatoria, si potrebbe dire, dei desideri. Ma, soprattutto, nello “scatto brusco dell’affermazione dell’istante, componente incatturabile dell’erotica puerile” (21).
L’ordine sovversivo che l’eros d’infanzia pone in essere ogni volta che si accende è anzitutto legato a questa componente di disordine, di parodia, di capovolgimento istantaneo per nulla preoccupato di lasciare tracce, di persistere, di approfittare di un possesso o di produrre una quota di godimento. Dunque, con Baudrillard, più sul versante della seduzione che del godimento, ma pur gaudente nella sua superficialità sfuggente. L’infanzia non disciplinata, non vigilata, non nurserizzata, per riprendere una metafora schéreriana, in fuga dallo sguardo reclusore del pedagogo, dal panottico pedagogico, in fuga da ogni principio di responsabilità e dai dover essere imposti dall’accelerazione del suo compiersi estinguendosi, l’infanzia gode della sua smisurata eccedenza, delle sue “folgorazioni passionali senza importanza”. In questo, secondo l’autore francese, essa si rivela più “simulacrale” che “reale”: è la potenza del falso, nel senso che Deleuze attribuisce a Nietzsche, e di più: “risalendo alla superficie, il simulacro fa cadere sotto la potenza del falso (fantasma) il Medesimo e il Simile, il modello e la copia. Rende impossibile sia l’ordine delle partecipazioni sia la fissità della distribuzione, sia la determinazione della gerarchia. Instaura il mondo delle distribuzioni nomadi e delle anarchie incoronate.” (Deleuze,Guattary 2006, 231).
L’eros infantile scuote ogni fondamento, nella lettura deleuziana che ne offre Schérer e in questa sua erranza di superficie, in questi effetti di scompaginamento e di simulazione sta il segreto di ciò che si appella “puerile”. Essa si muove ben al di fuori della prospettiva voyeristica di certa psicoanalisi. L’eros vagabondo dell’infanzia è ben altra cosa dal reticolato di fasi e fissazioni, di sindromi e di pulsioni che il Logos psicologico cerca di avvolgergli intorno per soffocarne la divergenza affermativa e implacabile. L’eros d’infanzia si esprime nel feticismo, nella funzione “irradiante” e non mascherante (quale verità?) del feticcio, così come nella metaforizzazione o “folklorizzazione” oscena della sessualità, come dice Schérer, che trasmuta gli organi sessuali in pezzi di materia, di natura, in cui “il sessuale propriamente inteso non è più che il punto di fissazione evanescente delle forze animali, vegetali, cosmiche, che si giocano in lui” (Schérer, 1978, 56) : il pene diventa “carota”, “salsiccia”, “fagiolino”. O ancora la fascinazione per il peto, “esplosione energetica”, “soffio e anima”, arriva a dire Schérer. Il gioco di scaricarsi peti nel viso a vicenda che l’autore porta a riprova della centralità erotica di questa gestualità infantile rafforza la teoria di un godimento decentrato rispetto alla teologia psicoanalitica e spostato sul piano di una passione per ciò che appartiene al livello animale, materico, scatologico. L’infanzia libera un erotismo inaccessibile e smisurato proprio perché estraneo ad ogni logica adulta, umanista o psicoanalitica che sia. Ed è questa la condizione della sua eterogeneità e della sua libertà. Altro che latenza e rinvio, come vorrebbe la morale borghese sanzionata dalla scienza, il bambino è davvero il perverso polimorfo di cui parla Freud, ma il suo Eros non è facilmente localizzabile, è pervasivo e intenso, simulacrale e estensivo, feticistico e transessuale, aperto e irriducibile, e, almeno fin tanto che non venga pedagogizzato e sorvegliato, è refrattario ad ogni logica legata al progetto monogamico e istituzionale.
In tal senso Schérer ha ragione di ricondurre a Fourier, che ha negato l’erotismo infantile nelle sue espressioni sessuali specifiche, in favore della libera espansione di altre manifestazioni del desiderio, una considerazione adeguata del nucleo passionale d’infanzia nei caratteri composto, seriale, collettivo. I bambini vivono l’eros in modo diffuso, spalmato sull’insieme di un’agire comunque fortemente erotizzato, sia esso legato alla rivalità, all’intrigo, alla cabala (le passioni cabalistiche, sfarfallanti e composte appunto di cui parla Fourier nel Nuovo Mondo Amoroso) e soprattutto le vivono in modo gruppale, collettivo, seriale, transizionale, al di fuori da ogni logica normata di coppia, di chiusura, di isolamento. L’eros infantile è generoso e moltiplicatore, non separa l’umano dall’animale e dal materiale, è nomadico e plastico, flessibile e metamorfico.
Riferimenti:
Bachelard Gaston (1972)
Poetica della rêverie (1960), tr.it. Dedalo, Bari
Deleuze Gilles Guattary Félix (2006)
Mille piani (1980), tr.it. Castelvecchi, Roma
Mottana Paolo (2002)
L'opera dello sguardo. Braci di pedagogia immaginale, Moretti e Vitali, Bergamo
Schérer René (1978)
Une érotique puérile, Galilée, Paris
Schérer René (2002)
Enfantines, Anthropos, Paris
Etichette:
divenire -infante,
Eros,
Gilles Deleuze,
infanzia,
James Hillman,
Otto Meyer-Amden,
René Schérer
giovedì 11 aprile 2013
Il brand sempreverde di Edipo

Avere degli schemi, più o meno essenziali, ma ferrei e radicati nella tradizione, è di grande conforto per chi li usa. E inoltre blandisce e rassicura, generando un sicuro successo. Gli schemi piacciono, specie quando confermano le semplificazioni, o quando possiedono un’intrinseca normatività. Oggi le opinioni prevalenti sono quasi sempre quelle che si avvalgono e si fondano su schemi ormai acquisiti, anche quando questi sono ampiamente superati o perlomeno contestati, confutati, criticati.
La prevedibilità delle opinioni dominanti, sapientemente amministrate da una piccola comunità di sedicenti esperti, spesso ormai arruolati nelle vesti appunto di opinionisti, è al limite dell’insostenibile. Eppure la norma che consente ad un’opinione, oppure anche di un parere effettivamente esperto, di candidarsi a posizioni di diffusione preminenti, è proprio quella che impone di mostrare il suo radicamento in schemi riconoscibili, meglio se ampiamente riconosciuti, nonostante talora ampiamente in decadenza. Per quanto mi riguarda, occupandomi di tematiche legate all’educazione, non finisco mai di stupirmi nel leggere articoli o nell’ascoltare interviste o rubriche, come oggi si definiscono, a cura di riconosciuti esperti, che ripetono come un mantra letture di fenomeni innervate dallo stesso vetusto bagaglio di categorie della cui fondatezza, anche solo storica, vi sono ottime ragioni perlomeno di dubitare.
Ma tutto questo non stupisce affatto. E’ una legge, una legge del potere, dei poteri, che si appoggiano sempre sulle letture facili, leggibili, e soprattutto rassicuranti. Si prenda per esempio la proliferazione di articoli, interviste televisive, rubriche che hanno ad oggetto i comportamenti giovanili. Qui oscilliamo spaventosamente tra letture puramente corrive, che attaccano la nuova ignoranza, il nuovo analfabetismo, la nuova violenza e così via (che di solito si appoggiano su rilievi statistici così riduttivi e capziosi da sfiorare la comicità: il 50% degli intervistati non conosce il significato della parola “usbergo” o cose del genere) a letture più colte e ampollose, sature di metafore e espressioni tecniche, che tuttavia confermano le medesime diagnosi, solo appoggiandosi su schemi sicuri. Sotto questo profilo, per esempio, mai come in questo periodo, è adoperato con sicuro effetto lo schema del complesso d’Edipo come grimaldello per sentenziare più o meno a morte sulla nuova gioventù. Dopo che per molti anni la psicoanalisi è stata piuttosto malvista nel mondo dell’opinione diffusa, oggi che è diventata una teoria normativa come un’altra, ecco che improvvisamente l’Edipo troneggia sui giornali anche più classicamente conservatori. E, si badi bene, non è un caso. Perché quando l’Edipo, -ormai un vero e proprio brand- che notoriamente ribadisce la necessità di figure genitoriali riconoscibili, di codici normativi cui sottostare, di castrazioni salvifiche e purtroppo non più somministrate con sufficiente tempismo, viene evocato, è tutta un’ideologia sociale molto precisa che viene implicitamente confermata. Un’ideologia sociale che rassicura molto chi non gradisce lo sfaldarsi dell’autorità, della famiglia, dei confini tra ruoli e generazioni, il nomadismo sessuale e così via.
Allo stesso modo le diagnosi che, sempre sullo stesso terreno, enfatizzano, sempre in ragione delle frane edipiche, l’affermarsi di soggetti narcisisti, fragili, incapaci di elaborare i fallimenti e che dunque implicitamente reclamano il ritorno a una normatività più decisa, ad una maggiore sorveglianza verso la nefasta deriva che conduce a scegliere il godimento anziché la fatica, è chiaro che tutto ciò non può che riempire di gioia chi si augura di poter amministrare soggetti più consapevoli del limite, del dovere, del sacrificio necessario a quella conformazione sociale cui non si sfugge, secondo tali profeti, senza pagare gravissimi prezzi.
Come dire: vecchi schemi e vecchie intramontabili politiche. Eppure sono decenni che si sono affermate, nei più diversi contesti disciplinari, dalla psicologia alla filosofia, alla sociologia all’antropologia, letture molto meno prescrittive intorno alla famiglia e al rapporto con il sapere, sia sul fronte della contestazione dell’alone appunto ideologico e deterministico dell’impostazione edipica, sia sul fronte di forme di vita del tutto irriducibili a tali formule e schemi. Letture che non assumono le nuove libertà dei soggetti e dei loro processi di soggettivazione sotto i paradigmi che hanno consentito di riconoscere i processi di antropogenesi europei dei secoli passati, ma che sono aperti al riconoscimento positivo di ipotesi di costruzione sociale che provengono da quella che, sotto gli occhi di tutti, è diventata una società plurale, in via di ampia contaminazione etnica, culturale, sessuale.
Curiosamente sui quotidiani e nelle grandi arene televisive capita molto di rado di ascoltare letture di marca antiedipica, o decostruzionista, o etnopsichiatrica, o queer sui destini della famiglia, della castrazione, del desiderio. A parlare, in un sol epico e marziale coro, sono gli scrittori-insegnanti incollati alle mitologie di una scuola e di un’adolescenza (peraltro solo nella loro privata autobiografia), tutta libri e belle lettere, politicamente attrezzata e serafica nell’olocausto dei propri godimenti a pro di carriere folgoranti, oppure gli psicoanalisti convertiti definitivamente alla norma, che pilotano l’Edipo come una macchina da guerra all’incontrario.
Di fronte al loro parere inconfutabile, siamo costretti, sono costretto, a continuamente veder esecrata una gioventù che, personalmente, trovo molto meglio della mia, molto più informata, libera, meno dipendente, meno inibita, meno ideologica, una generazione che, anche grazie a cellulari e social network, scrive, scrive moltissimo e non solo poesie o diari lacrimosi e disperati, e che forse ci regalerà un mondo, me lo auguro, che ridimensioni definitivamente la famiglia come la conosciamo, e con essa una scuola che ha ancora gli stessi muri dei manicomi e delle carceri e che arranca da sempre a costruire interesse intorno alla cultura. Per rimpiazzarle, mi auguro, con altre forme societarie e con luoghi dell’imparare finalmente scelti, consapevolmente, in cui ciò che si fa sia desiderabile, partecipabile, alla lunga in grado di suscitare non odio ma amore, amore per il sapere e per l’emancipazione che da un'autentica conoscenza diffusa può derivare. Oltre gli schemi vetusti e il moralismo e il normativismo che cola dai nostri media asserviti, con i suoi testimoni -pochi, cattivi e privilegiati-, come pece bollente.
Etichette:
antiedipo,
castrazione,
diagnosi,
edipo,
famiglia,
giovani,
legge,
norma,
psicoanalisi,
queer
lunedì 8 aprile 2013
sabato 6 aprile 2013
venerdì 22 marzo 2013
Per chi ha orecchie dure (e troppo lunghe): cosa è controeducazione

Controeducazione è questo: difendere e incrementare il diritto sovrano ad affermare l’intensità della vita. Da questa considerazione apparentemente elementare discendono un numero considerevole di conseguenze.
Che, per esempio, ci si impegni alacremente a impedire che la vita venga derubata, saccheggiata, deprivata o ostacolata nel suo sacrosanto diritto ad essere e ad essere nei modi che le convengono, in ogni situazione, educativa ma non solo. Dunque ad impedire che, come purtroppo spesso accade, la vita sia revocata e marginalizzata dai luoghi dell’educazione. Impedire che la scuola si trasformi, come spesso accade, in una prigione, in una trappola, in un luogo di internamento precoce all’interno del quale le risorse vitali, i desideri, le possibilità sono sistematicamente sabotati, perseguitati, interdetti, per sostituirvi procedure di manipolazione sistematica, di disciplinamento, di soggiogamento dei corpi, delle menti e delle emozioni.
Lottare con tutte le proprie forze contro gli ideologi di questa repressione, contro gli ascetisti volgari, contro i teoreti della fatica e del sacrificio, contro gli psicologi che vaticinano destini mortiferi a chi non sappia piegarsi al giogo dell’obbedienza e della coercizione. Significa perseguire al contrario l’idea che sempre e ovunque, qui ed ora, occorre affermare la necessità di un’esperienza plenaria, ricca, vissuta intensamente. E che è grazie ad essa che la vita assume senso, non in virtù di improbabili finalizzazioni di compimento in articulo mortis. Non c’è alcuna saggezza da raggiungere che non sia quella della piena adesione all’esperienza immediata da subito e per sempre. Che non sia la necessità che il desiderio sia sempre il criterio dirimente della sensatezza di un coinvolgimento, di un’azione, di una fatica, qualora essa risulti necessaria per adempiervi.
La controeducazione significa sostituire la volontà di libertà leonina al dovere astratto e caritatevole del cammello, per parafrasare Nietzsche. Volontà di entrare nel circolo di un’esistenza che non si consuma nell’attesa di qualcosa ma che è da subito e continuamente adempimento della pienezza che ogni istante reclama di possedere. Il che non significa una mera esaltazione della gioia, del godimento, del riso (per quanto, come ancora ci ricordava Nietzsche, il riso è il miglior modo per uccidere…). La pienezza è affermazione dell’intensità del vivere, nella sua inesauribile gamma di sfumature, che comprendono irriducibilmente le frequenze più luminose e quelle più buie, le emozioni di piacere più irrefrenabile e quelle di malinconia, di dolore, di mancanza più lancinanti. In una compresenza che è sempre e comunque, quando non gratuita e vessatoria, affermazione vitale.
Controeducazione è piena affermazione del tutto della vita perché essa non sia più derubata, non sia sottomessa, non sia barattata e sfruttata per sostenere l’intensità di alcuni, il loro godimento, il loro dominio, la loro possibilità contro l’impossibilità dei molti.
Niente di utopico, come si vede, solo una caparbia affermazione di giustizia, contro la rassegnazione e l’adattamento, contro l’acquiescenza e la complicità con modelli di educazione che fomentano la passività, la dipendenza, la mortificazione di tutto ciò che non sia conforme, ordinato, prescritto e sottomesso.
Controeducazione è difesa dell’idea che non esiste affermazione di sé in assenza dell’affermazione della vita del tutto. In polemica quindi con gli edonismi puramente individualistici, con il loro nichilismo implicito, e non certo in nome di una benevolenza e di una carità che vuole tutti solidali nella sofferenza e nel martirio. Al contrario nella consapevolezza che il piacere, che l’intensità, che pure si nutrono talora anche del male in tutte le sue forme, non possono mai prescindere dalla possibilità che tutti condividano una tale intensità. Tutti nel senso non solo dell’umanità, presunto baricentro del tutto, ma il tutto nel senso della materia, della natura, delle cose. Tutti godiamo nel bene e nel male, o meglio al di là del bene e del male, ma non mai contro il tutto o contro l’affermazione vitale di esso.
Talora il piacere di uno può generare il dispiacere di un altro, ma solo nella consapevolezza che l’accesso al godimento e al piacere sono l’orizzonte ultimativo cui debbono soggiacere tutte le forme di vita, anche quelle in cui la vita si manifesta in modo silenzioso o immobile.
Giustamente Georges Bataille, evocando il Vangelo, sosteneva che chi cerca di salvare la propria vita, la perderà. Evocazione e reinterpretazione di un passaggio che si rendeva, ipso facto, affermazione dell’eccesso e del perseguimento della dépense e del lusso sfrenato.
Condivido questo richiamo e al tempo stesso lo voglio corroborare con l’idea che il piacere non è un destino ma una conquista, che l’intensità è il frutto anche di un’operatività attenta, sensibile, educata, che godere è, nell’umano, una progressiva forma di affinamento (Vaneigem).
Questa è una controeducazione conseguente: l’affinamento molteplice della nostra sensibilità, del nostro gusto, della nostra capacità di fare di ogni gesto della vita una continua occasione di arricchimento plenario, dove la testa che conosce non è mai staccata dal corpo che sente e dove il godimento del corpo che sente non è mai staccata da una testa che percepisce, elabora, assorbe in un reticolo di corrispondenze di illimitata potenza.
Una controeducazione siffatta ha una lunga tradizione alle spalle, di pensiero poetante, di pratiche emozionate, di esperienze vissute. A tutto questo, a questo sapere integro e entusiasmante, essa si appella, per avviare il superamento del nulla, l’impoverimento del mondo, la malattia proliferante del nostro tempo.
E non per domani, non per il regno millenario a venire, ma da subito, in questa ora, in questo scritto, in tutto quello che immediatamente ne potrà scaturire.
Per rovesciare l’assetto del nostro insensato, insostenibile, incurante fare e sostituirvi un più appassionato, accurato e armonico essere.
Etichette:
controeducazione,
essere,
fare,
Georges Bataille,
godimento,
nietzsche,
pensiero poetante,
piacere,
scuola,
Vaneigem,
Vangelo
lunedì 18 marzo 2013
martedì 5 marzo 2013
Genitori permissivi e insegnanti perseguitati?

Ora, sembra che ciò sconvolga molto chi ha sempre creduto che scuola e famiglia dovessero stringere un patto di solidarietà contro i ragazzi, un patto disciplinare e normativo, quello che ha dominato per anni e in virtù del quale i ragazzi cercavano di tenere nascoste eventuali “monellerie” compiute a scuola o giudizi negativi degli insegnanti. Quel patto che spesso raddoppiava le umiliazioni patite a scuola con quelle patite a casa. Dove il cattivo voto diventava punizione (spesso fisica) in famiglia. Un mondo che riteneva i ragazzi alla mercé del mondo adulto, che poteva disporne a piacimento, essendo inteso che i ragazzi non avevano titolo ad esercitare alcuna decisione in proprio (almeno fino alla maggiore età) e che tutto ciò che veniva fatto, veniva fatto sempre per il loro bene. Sappiamo come funzionava tutto ciò. Si trattava di un sistema repressivo, violento, che forse (e sottolineo il forse) conseguiva alcuni obiettivi formativi per altro assai discutibili (una certa disponibilità al’obbedienza, alla dipendenza e alla sottomissione) ma indubbiamente favoriva nevrosi e complessi di ogni genere. Oggi le famiglie, in larga misura, sono cambiate. Abbiamo assistito al germoglio della famiglia “affettiva”, che vezzeggia i suoi virgulti, li ascolta, li difende, li assolve persino.
A prima vista non mi pare tanto male, se è così. Credo che una famiglia del genere non sia da considerarsi poi tanto strana se tenda a prendere le difese di un figlio che si lamenta di essere stato maltrattato da un adulto in altra sede, sia esso insegnante, prete o allenatore (ricordiamoci che molti ragazzi e ragazze per anni e per secoli non hanno avuto il coraggio di denunciare gli abusi di cui sono stati vittime, in famiglia o al di fuori di essa, anche in virtù di un atteggiamento di sottomissione e di mancanza di interlocutori adulti validi). Certo questo può produrre qualche inconveniente: i ragazzi che non amano un adulto possono calunniarlo o farlo perseguitare per sciocchezze. Ma questo è un dato ormai ineliminabile e che, a mio giudizio, dovrebbe indurre la scuola e gli insegnanti alla massima accortezza riguardo ai loro metodi normativi. Essi non vanno più di moda, quali che siano. Occorre che ogni sanzione sia sempre ben giustificata e giustificata in primis ai ragazzi stessi, che ormai hanno imparato a difendersi e anche a offendere, facendo leva sulla protezione che i genitori di oggi sono disposti a fornire loro.
Sequestare un cellulare può sembrare un fatto ovvio. Ma è davvero così? Perché occorre sequestrare un cellulare? Il vero problema non sarà che spesso gli insegnanti non riescono a suscitare l’interesse necessario a rendere non necessariamente preferibile distrarsi con il cellulare? Mi rendo conto che non sia facile ma indubbiamente oggi il problema è questo. Stare a scuola non è più un fatto così pacificamente accettato. Né dagli allievi né dai genitori. Occorre che la scuola conquisti una sua autorevolezza fondata sui fatti, non sulla disciplina. E che impari a persuadere i suoi allievi, obbligati a frequentarla, e sottolineo obbligati, che vale la pena essere lì. Che vale la pena persino spegnere o silenziare il proprio cellulare.
Mi pare onesto. Se io dovessi essere obbligato a trascorrere ore e ore in un luogo tutt’altro che attraente, in compagnia di adulti spesso tutt’altro che interessanti, a fare cose che reputo tutt’altro che di mio gusto, dubito che sarei contento se mi sequestrassero una finestra sul mondo come può essere considerato il cellulare o simili. Credo che occorra finirla con una cultura che ha dato per scontate molte cose, anche che essere a scuola sia un fatto di per sé educativo in quanto obbligatorio o in quanto normato da un sistema disciplinare spesso violento e incurante della sensibilità di bambini e ragazzi. E’ una cultura di cui occorrerebbe vergognarsi più che avvertire la nostalgia.
Forse oggi i genitori, anche per compensare alle loro manchevolezze, alla loro mancanza di tempo, alla loro distrazione, sentono la necessità di riconquistare l’amore dei figli anche con un eccesso di protezione. Può darsi, come può darsi che questo indebolisca i ragazzi e li renda più fragili. Queste spiegazioni, queste diagnosi non mi convincono fino in fondo. I ragazzi di un tempo erano spesso molto vili, molto dipendenti, molto incapaci di farsi valere di fronte all’autorità. Oggi essi non amano farsi mortificare e hanno imparato a reagire. Credo sia un buon segno. Un segno di cui forse, molto presto, ci si accorgerà anche in altri contesti sociali e politici. E’ colpa della famiglia affettiva, della società permissiva, della caduta dei “valori”, quelli dell’obbedienza, della norma e del dovere? Beh, se è così ben venga. Ben venga la fine di un sistema di oppressione di cui ritengo che la gran parte dei bambini e dei ragazzi di questo mondo abbiano il diritto di essere definitivamente esonerati.
Questo non significa assolverli sempre e comunque ma, come per gli adulti, ritenerli persone con pieni diritti, con i quali ogni gesto, ogni imposizione, ogni richiesta deve essere spiegati, legittimati, concordati. Altro che scuola della frustrazione, del sacrificio e della sanzione!
Etichette:
diritti,
disciplina,
famiglia,
genitori permissivi,
insegnanti,
scuola
Iscriviti a:
Post (Atom)





